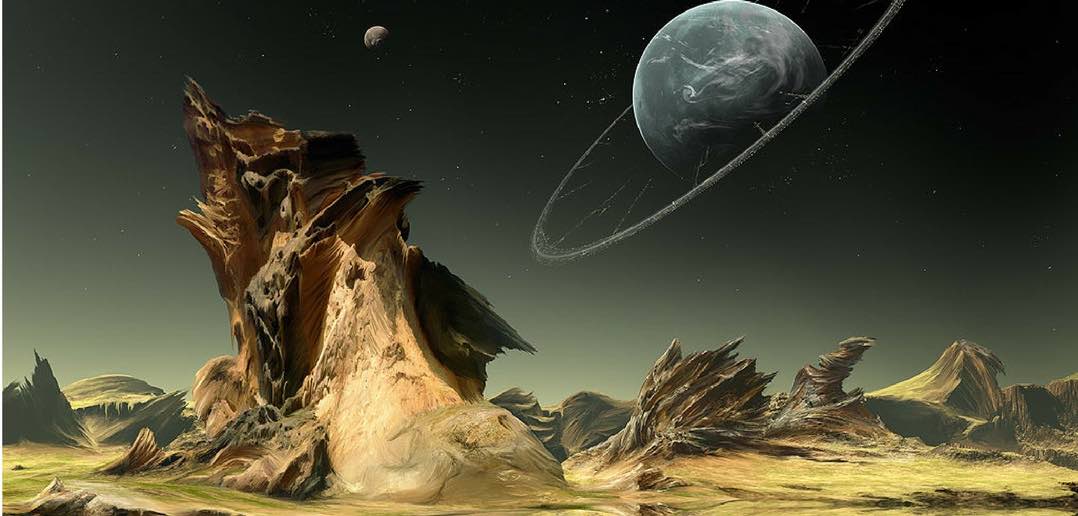Le travi sotto il pavimento dell’universo
di Luca Bianco
dal numero di settembre 2016
 La prima traduzione italiana di Io sono vivo, voi siete morti usciva ventun anni fa per i tipi di Theoria (cfr. «L’indice», 1996, n. 2). Allora Emmanuel Carrère non era ancora diventato lo scrittore che conosciamo oggi, l’elegante e intelligente campione di un’autofiction che gioca a rimpiattino con le realtà più scabrose e scomode, anche disposto a mettersi a nudo di fronte al lettore, ma sempre nel calcolo di una raffinata e iperletteraria messa in scena autobiografica. Non era ancora, insomma, l’autore di L’avversario (Einaudi, 2000, poi Adelphi, 2013, forse a tutt’oggi il suo capolavoro) né quello di Limonov (Adelphi, 2012, il libro che ne ha decretato il successo). Nel 1996, per il lettore italiano, Carrère era invece soprattutto l’autore di due piccoli gioielli di inquietudine come Baffi (Theoria, 1988, poi Bompiani, 2000, ora fuori catalogo) e La settimana bianca (Einaudi, 1996, poi Adelphi, 2014).
La prima traduzione italiana di Io sono vivo, voi siete morti usciva ventun anni fa per i tipi di Theoria (cfr. «L’indice», 1996, n. 2). Allora Emmanuel Carrère non era ancora diventato lo scrittore che conosciamo oggi, l’elegante e intelligente campione di un’autofiction che gioca a rimpiattino con le realtà più scabrose e scomode, anche disposto a mettersi a nudo di fronte al lettore, ma sempre nel calcolo di una raffinata e iperletteraria messa in scena autobiografica. Non era ancora, insomma, l’autore di L’avversario (Einaudi, 2000, poi Adelphi, 2013, forse a tutt’oggi il suo capolavoro) né quello di Limonov (Adelphi, 2012, il libro che ne ha decretato il successo). Nel 1996, per il lettore italiano, Carrère era invece soprattutto l’autore di due piccoli gioielli di inquietudine come Baffi (Theoria, 1988, poi Bompiani, 2000, ora fuori catalogo) e La settimana bianca (Einaudi, 1996, poi Adelphi, 2014).
Io sono vivo e voi siete morti portava nell’edizione Theoria il sottotitolo Philip Dick 1928-1982. Una Biografia. Era un sottotitolo menzognero, ma accattivante, soprattutto perché era relativamente da poco iniziata l’opera di rivalutazione della figura di Dick, e i suoi libri venivano fatti oggetto di una sistematica campagna di nuove edizioni per l’editore Fanucci, emancipandosi dal ghetto specialistico della fantascienza e delle collane da edicola; possiamo in fin dei conti dire che, così come Carrère non era ancora Carrère, neppure Dick era ancora il Dick che conosciamo oggi, pur avendo di fatto chiuso i suoi conti anagrafici con questo pianeta nel 1982.
Prodromi di prove future
Il libro di Carrère non è una vera biografia, e non è nemmeno un saggio critico sull’opera del grande, grandissimo scrittore americano; è piuttosto un incunabolo, un prodromo delle prove del Carrère maggiore e più noto. È come se lo scrittore, dopo aver fissato lo scarno canovaccio biografico delle vicende terrene di Philip Kindred Dick, vi proiettasse sopra, quasi in sovraimpressione, il fantasmagorico film del percorso intellettuale, psicologico e (soprattutto) narrativo del Dick scrittore, concentrandosi in particolare sui momenti in cui la vita reale di Dick e le storie che Dick racconta vengono a sovrapporsi. Uno degli aspetti più affascinanti del libro è che la sovrapposizione non implica mai una coincidenza perfetta, ed è proprio sui margini, nelle zone discrepanti e confuse ai bordi delle immagini, che risiedono i momenti più efficaci.

Ritratto di Philip Dick
Era del resto una verità riconosciuta e alimentata dallo stesso autore di La svastica sul sole, quella secondo la quale la vita di Philip K. Dick, soprattutto negli ultimi anni, era venuta ad assomigliare a un romanzo di Philip K. Dick. È istruttivo, a questo proposito, accostare alla lettura del libro di Carrère quella della bella e documentatissima biografia «ufficiale» di Lawrence Sutin Divine invasioni. La vita di Philip K. Dick (Fanucci, 2001) per avere la misura di come i traumi infantili, l’irrequieta vita sentimentale, la frequentazione degli ambienti della controcultura californiana, l’uso e l’abuso di sostanze psicotrope (anfetamine e psicofarmaci su tutte) e, da ultimo, la cruciale e inclassificabile esperienza religiosa che Dick visse nel 1974 abbiano contribuito a plasmare l’immaginario da cui lo scrittore attingeva per i suoi romanzi, racconti e saggi, ai quali, davvero, l’etichetta di «fantascienza» va stretta. Non conosco altri casi in cui la science-fiction si compenetri altrettanto indissolubilmente con l’autofiction, e questo prima che il termine stesso di autofiction venisse inventato.
Dick agli inizi sognava di diventare uno scrittore mainstream, e fece alcuni sfortunati tentativi in tal senso: sono romanzi che si trascinano, come i loro protagonisti, tra crisi matrimoniali, esistenze marginali, macerazioni esistenziali, come quelli di un John Williams qualsiasi. Ma la vera cifra della sua grandezza sta nell’aver scelto, dapprima controvoglia e poi consapevolmente e felicemente, la letteratura di genere, e nel saper trasformare, per esempio, una banale storia di adulterio in un intreccio da cui dipendono, quando va bene, i destini della terra, e, quando va male, i fondamenti stessi della realtà. Ma il cortocircuito tra arte e vita che è al centro del libro di Carrère funziona anche in senso inverso. Le ossessioni di Dick alimentano i suoi romanzi, e, soprattutto dopo il 1974, i romanzi di Dick, quelli già scritti e quelli che sta scrivendo, alimentano le sue ossessioni. Di fronte a questa materia così incandescente, Emmanuel Carrère, per la prima volta nella sua carriera, fa quello che poi farà di fronte al Jean Claude Romand di L’avversario o a Eduard Limonov: sospende il giudizio e racconta, con quella sua prosa esatta e levigata che illumina le trappole e gli abissi della psiche, senza disinnescare le prime o rischiarare i secondi.
Risalire alla preistoria
Ma Io sono vivo, voi siete morti non andrebbe letto solo per ritrovarvi il Carrère che sarà; si tratta di una tappa in un percorso iniziato ben prima. Credo valga la pena di risalire addirittura alla preistoria dello scrittore, al suo primissimo libro, datato al 1982. Il venticinquenne Carrère era allora una firma della prestigiosa rivista di cinema «Positif», e dava alle stampe una monografia su un grande regista visionario, un altro di quegli autori per i quali la vita e l’opera molto spesso vengono a sovrapporsi: sto parlando di Werner Herzog, che come narratore di ossessioni non è secondo a nessuno, come sa chi ha visto almeno Aguirre e Fitzcarraldo; e anche credo valga la pena di notare che il secondo romanzo di Carrère Bravura (Theoria, 1987, ora fuori catalogo), traeva il suo spunto narrativo proprio da uno dei momenti epocali della letteratura fantastica tutta, quell’estate del 1816 in cui, a villa Diodati a Ginevra, Mary e Percy Shelley, insieme a Lord Byron e al medico John Polidori, decisero di scrivere ciascuno una storia dell’orrore (l’attenzione di Carrère si concentra su Polidori, ma sullo sfondo c’è ovviamente il Frakenstein della Shelley).

Una scena di “Fitzcarraldo” di Werner Herzog
In Francia, del resto, a differenza che da noi, la letteratura cosiddetta «di genere» ha sempre intrattenuto scambi assai proficui con quella sedicente «alta»: nel 1991, appena due anni prima che Carrère affrontasse da par suo la vita e l’opera di Dick, un altro grande scrittore contemporaneo francese, Michel Houellebecq, ingaggiava un breve ma serrato e intenso corpo a corpo con uno scrittore che sia Dick sia Carrère conoscevano e amavano: il risultato è il memorabile H.P. Lovecraft. Contro il mondo, contro la vita (Bompiani, 2001), straordinaria riflessione su un altro demiurgo di ossessioni la cui potenza immaginativa gareggia sul filo di lana con quella di Dick.
Il quale Philip K. Dick, vivo o morto che sia, ha le spalle abbastanza larghe per mantenersi irriducibile a quello che i suoi pur benintenzionati glossatori interpreti e biografi vorrebbero che fosse. Quanto larghe siano quelle spalle lo dimostra la mole di L’esegesi. 2-3-74: sono milletrecento pagine, e non sono che un’infinitesima parte del materiale che Dick scrisse, senza volerlo per forza destinare alla pubblicazione, tra il 1974 e la data della sua morte. Come scrivono i due curatori Pamela Jackson e Jonathan Lethem (l’autore, tra gli altri, del bellissimo La fortezza della solitudine, Marco Tropea, 2004), «Dick scelse di chiamare questi scritti la sua Esegesi. Il processo della sua produzione fu frenetico, ossessivo e, può essere giusto precisarlo, involontario. La creazione dell’Esegesi fu un atto di sopravvivenza umana di fronte a una crisi sia intellettuale che emozionale che alterava la vita: la crisi della rivelazione». Tra il febbraio e il marzo 1974, infatti, Philip Dick ebbe un’intensissima esperienza psichica che cambiò la sua vita e la sua concezione di realtà. Non è possibile definire in due righe un evento che lo stesso protagonista non riuscirà a descrivere e spiegare compiutamente in oltre diecimila pagine (è da lì che viene l’Esegesi che Fanucci ha ora tradotto, purtroppo in modo non impeccabile: basti dire che il sommo Art Spiegelman, l’autore di Maus, diventa «il disegnatore di cartoni animati Art Spiegelman»); diciamo che ha a che fare con una conversione religiosa innescata dalla visione di un ciondolo a forma di pesce, simbolo dei primi cristiani, e che comprende numerose visioni ipnagogiche e non, di cui una rivelò a Philip la malformazione congenita asintomatica del figlio Christopher che, se non operata, avrebbe portato alla morte. La diagnosi fu confermata dai medici parola per parola, e Christopher si salvò.
Diciamo anche che Dick, ossessivamente, riempì pagine su pagine per tentare di chiarire, anzitutto a se stesso, la natura di quell’esperienza, non tralasciando alcuna ipotesi, da quelle più ovvie, di natura psicologica, psichiatrica, farmacologica, a quelle più improbabili, di natura religiosa, sovrannaturale, (fanta)scientifica. Detta così spaventerebbe chiunque, allontanandolo per sempre dal libro. Ma i lettori di Philip K. Dick non sono chiunque: loro sanno che, se a raccontarle è l’autore di Ubik, di Noi marziani, di Un oscuro scrutare e di tutti gli altri capolavori che portano la sua firma, anche le ipotesi più deliranti e improbabili (soprattutto le più deliranti e improbabili) avranno la loro ragione di essere lette. E che anche in questo confuso, frammentario, profondo e a tratti esilarante libro, accadrà proprio come in molti altri libri di Dick: «Credo che sia quello che faccio sempre, scrivendo: analizzo l’universo per vedere cosa gli succede. Nei miei romanzi sono visibili le travi sotto il pavimento dell’universo».
lucaxbianco@gmail.com
L Bianco è storico dell’arte, traduttore e iconografo