Nel caleidoscopio umano di North West London
recensione di Franco Marenco
dal numero di novembre 2013
Zadie Smith
NW
ed. orig. 2013
trad. dall’inglese di Silvia Pareschi
pp. 356, € 18
Mondadori, Milano 2013
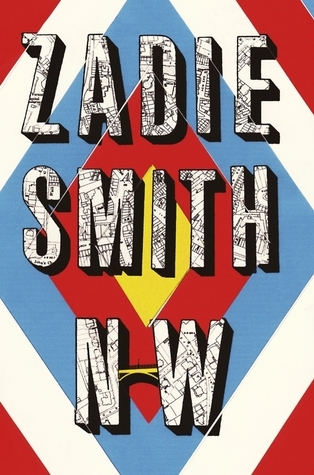 Un racconto paradossale: intitolato a un’area postale di Londra che comprende alcuni quartieri a nord-ovest, estesi ma pur sempre locali, molto locali; e poi, in essi, un mondo misto e cosmopolita, anzi, il mondo, l’intero universo degli umani e delle loro etnie: inglesi, indiani, bangladeshi, giamaicani, nigeriani, polacchi, italiani, coreani, cinesi ecc., che mescolano le loro provenienze in un’unica lingua che innovano, storpiano, allargano, sconvolgono ogni giorno con infiniti accenti, inflessioni, ripetizioni, amputazioni, prestiti, sincopi, frasi fatte, idioletti personali. Un universo alla continua scoperta di se stesso, negli ambiti più bassi e miseri come nei circoli più alti e orgogliosi. Insomma, un microcosmo dove il micro e il cosmo vogliono tutti e due la loro parte. Paradossale allora, ma anche ironico: ironico specialmente nei confronti di chi, come in genere noi italiani, ha perso l’abitudine di confrontarsi con il mondo, non guarda al di là del proprio orto e anzi vi ci vuole a tutti i costi campare e deperire, in un orizzonte sempre più meschino, respingendo tutti coloro che chiedono di entrarvi e portarvi nuova linfa, nuove idee, nuove sensibilità ed emozioni. Zadie Smith è figlia di un inglese e di una giamaicana, ha vissuto in Italia e insegna ad Harvard, scrive racconti sui rapporti fra le razze in Inghilterra (Denti bianchi, 2000) e nel mondo anglosassone (Della bellezza, 2005) non nascondendo, pur molto implicitamente, prospettive di somiglianza e promiscuità senza mai calcare la mano, senza proclami di alcun genere, anzi considerando la cosa come una necessità naturale, un dato di fatto normale e accertato nei mille modi di vivere e morire che coesistono più o meno felicemente in posti, appunto, come il North-West di Londra, che è poi anche un’allegoria dei rapporti fra il Nord dell’Europa e l’Ovest delle antiche colonie, piene di razze mescolate e ormai indistinguibili (conosco una famiglia americana di ascendenza cinese-giamaicana-ebrea, cioè giallo-nero-bianca, molto unita e inconsapevole di distinzioni, e direi molto established, a proprio agio, fiera di sé).
Un racconto paradossale: intitolato a un’area postale di Londra che comprende alcuni quartieri a nord-ovest, estesi ma pur sempre locali, molto locali; e poi, in essi, un mondo misto e cosmopolita, anzi, il mondo, l’intero universo degli umani e delle loro etnie: inglesi, indiani, bangladeshi, giamaicani, nigeriani, polacchi, italiani, coreani, cinesi ecc., che mescolano le loro provenienze in un’unica lingua che innovano, storpiano, allargano, sconvolgono ogni giorno con infiniti accenti, inflessioni, ripetizioni, amputazioni, prestiti, sincopi, frasi fatte, idioletti personali. Un universo alla continua scoperta di se stesso, negli ambiti più bassi e miseri come nei circoli più alti e orgogliosi. Insomma, un microcosmo dove il micro e il cosmo vogliono tutti e due la loro parte. Paradossale allora, ma anche ironico: ironico specialmente nei confronti di chi, come in genere noi italiani, ha perso l’abitudine di confrontarsi con il mondo, non guarda al di là del proprio orto e anzi vi ci vuole a tutti i costi campare e deperire, in un orizzonte sempre più meschino, respingendo tutti coloro che chiedono di entrarvi e portarvi nuova linfa, nuove idee, nuove sensibilità ed emozioni. Zadie Smith è figlia di un inglese e di una giamaicana, ha vissuto in Italia e insegna ad Harvard, scrive racconti sui rapporti fra le razze in Inghilterra (Denti bianchi, 2000) e nel mondo anglosassone (Della bellezza, 2005) non nascondendo, pur molto implicitamente, prospettive di somiglianza e promiscuità senza mai calcare la mano, senza proclami di alcun genere, anzi considerando la cosa come una necessità naturale, un dato di fatto normale e accertato nei mille modi di vivere e morire che coesistono più o meno felicemente in posti, appunto, come il North-West di Londra, che è poi anche un’allegoria dei rapporti fra il Nord dell’Europa e l’Ovest delle antiche colonie, piene di razze mescolate e ormai indistinguibili (conosco una famiglia americana di ascendenza cinese-giamaicana-ebrea, cioè giallo-nero-bianca, molto unita e inconsapevole di distinzioni, e direi molto established, a proprio agio, fiera di sé).
Le etnie principali in NW sono quelle di antiche marginalità: bianche (irlandesi, qualche inglese), nere (giamaicani, forse nigeriani, forse ghanesi), asiatiche (forse indiani). Ho dovuto usare molti “forse” perché da questo punto di vista nulla è mai sicuro: che uno sia bianco o nero ecc. lo si dice solo occasionalmente, quando c’è da individuare uno nella folla che poi scompare immediatamente. Ma ho stentato, leggendo il testo inglese, a capire di che colore fossero i protagonisti, e sono tanti. L’autrice non li qualifica mai in questo modo, non vuole servirsene, perché – è una delle sue lezioni – non serve più. L’ambiente è quello delle case a schiera dei quartieri operai o ex tali, e delle new towns costruite nel dopoguerra ai margini delle città più vecchie e subito inglobate in esse, con gli immensi torrioni residenziali che oggi possono essere simbolo di degrado ma che hanno fornito all’Inghilterra le leve giovanili dello sviluppo, grazie all’abbondanza di scuole, di università basate sul merito, di professioni aperte: margini di Londra, presto evoluti in centro del mondo.
Centrali nel racconto sono due figure femminili, Leah Hanwell, di madre irlandese (questa almeno è certa), e Keysha Blake, giamaicana (nera), che poi si fa chiamare Natalie. Sono bambine e amiche insieme, crescono, ammirano il ragazzo Nathan (nero? bianco? chissà: da qualche parte sarà pur detto, ma non importa), si istruiscono a vicenda sul sesso e i modi di goderne, affrontano con assoluta indifferenza le prime esperienze in questo campo, vengono separare da nuovi gusti, nuove droghe e nuovi stili musicali, vanno all’università, si sposano, nel senso che Natalie va in viaggio di nozze a Positano con il bel Frank De Angelis, “raro italiano negroide” frutto dell’incontro in un parco fra una ereditiera italiana e un ferroviere di Trinidad, e Leah sta con un bel ragazzo anche lei, nigeriano-francese molto molto nero, e non vuole bambini.
Poi Leah si impiega in Comune (Council, non Consiglio come dice la traduzione) e Natalie diventa avvocato, ma commette la stramberia di curiosare nel covo di due ragazzi che praticano il sesso virtuale e all’occorrenza materiale, si stende su un materasso – cosa state a giocare con il computer quando avete a portata di mano the real thing! – e comanda lei le operazioni senza capire che quelli stanno filmando tutto (da quel capriccio non affiorano motivazioni, solo indebite sensazioni). Il video è visto in casa, lei si confonde e vaga smarrita fra città e campagna, poi si riscatta accudendo i figli, ma rimane irrimediabilmente isolata dal marito. Intanto nel pacifico NW è stato commesso un delitto, Leah si deprime, Natalie forse scopre chi è stato – Nathan? – ma non lo sapremo mai. Il racconto si chiude su questa nota di tristezza e di vacuità di destini incrociati ma non veramente integrati, come lo sono invece le provenienze e le qualità umane: insomma, il problema rimane. Intorno a questo centro femminile i personaggi maschili: Frank debole, Michel limitato, Rodney religioso e arido, Felix in fuga da Annie, molto posh ma incapace di smettere con la droga, Nathan che dal ragazzino stupendo che era è diventato un relitto umano, prossimo alla disfatta.
Il problema rimane, eccome: chissà se l’autrice ha concepito questo finale amaro prima di cominciare a scrivere, o se le è stato imposto dagli sviluppi degli ultimi anni, con il fallimento del multiculturalismo predicato da molti, fra cui Tony Blair. Quel che conta però non sono tanto le vicende di questa o di quello, quanto lo stile con cui vengono descritte, sempre all’insegna dell’ibridismo. Ibridismo di etnie e religioni, di colori e caratteri, ma anche e soprattutto di gerghi e linguaggi, dall’informatico al lirico-popolare al formulare-religioso al poetico-infantile all’erudito. Per imparare qualcosa sugli straordinari manierismi della fetta più tradizionale e istruita della società bisogna leggere le battute della ricca tossicodipendente (Shakespeare, la Bibbia e il marciapiede assimilati), per capire Nathan bisogna sforzarsi di connettere monosillabo a monosillabo, per farsi un’idea del temperamento di Natalie bisogna sentirla conversare con la madre e poi con i colleghi avvocati, per capire l’affetto bisogna ascoltare le donne, gli uomini in questo sono muti (e in certi dialoghi fra uomo e donna le battute sono mescolate in modo da rendere difficile distinguere chi dei due le pronuncia). Fra tanti estremi, i mille registri e le mille sfumature di un macrocosmo espressivo di incredibile flessibilità e ricchezza (enormemente difficile da rendere in traduzione: l’ottima Silvia Pareschi ha a che fare con due lingue ormai incommensurabili, salvo dove si voglia chiedere aiuto ai nostri dialetti, soluzione povera anch’essa).
Sono parte di questo stile la scrupolosissima accuratezza di ogni vocabolo, l’assenza di una trama (è piuttosto una serie di impressioni e notazioni di cronaca), la concentrazione sui dati della coscienza e il conseguente oscuramento di oggetti ed esteriorità varie – sì, un flusso di coscienza vero e proprio, vicino ai grandi esempi novecenteschi – l’inizio delle frasi in medias res e la conclusione spesso tronca, il passaggio inavvertito da un pensiero a un altro, le conversazioni frante, le immagini irrelate (ad esempio i dettagli di un caso legale mescolati alle osservazioni in un museo anatomico), le ironie continue e i momenti di genuino buon umore, e sopra tutto la cancellazione di ogni posizione astratta, di ogni possibile teoria pur a contatto con materie che di grande riflessione avrebbero bisogno. Smith attinge all’altro canale, quello solo induttivo della narrazione cioè della prassi: un libro, il suo, per chiunque voglia sentirsi parte della postmodernità, e della fatica di trovare un senso anche dove un senso non c’è, o non c’è più.
marencof@tin.it
F Marenco è professore emerito di letterature comparate all’Università di Torino
Avvistare le volpi lungo i binari della metro: sul numero di novembre 2013 anche Maria Paola Guarducci recensisce NW di Zadie Smith.




