Il popolo a parte
recensione di Anna Nadotti
dagli archivi: 2002 – anno XIX – n. 9
Svetlana Aleksievič
PREGHIERA PER ČERNOBYL’
ed. orig. 1997, traduz. dal russo di Sergio Rapetti
pp. 287, € 15
e/o, Roma 2002
Sulla base dei rilevamenti, venne registrato un insolito livello di radioattività il 29 aprile 1986 in Polonia, Germania, Austria, Romania, il 30 aprile in Svizzera e Italia settentrionale, dall’1 al 2 maggio in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Grecia settentrionale, il 3 maggio in Israele, Kuwait e Turchia. Le sostanze gassose e volatili furono proiettate a considerevole altezza e la loro dispersione fu globale: il 2 maggio vennero registrate in Giappone, il 4 maggio in Cina, il 5 maggio in India, il 5 e il 6 maggio negli Stati Uniti e in Canada. Ci volle meno di una settimana perché Černobyl’ diventasse un problema per il mondo intero.
Di che cosa parla questo libro? Perché l’ho scritto? Questo libro non parla di Černobyl’ in quanto tale, ma del suo mondo. Proprio di ciò che conosciamo meno. O quasi per niente. La storia mancata: ecco come avrei potuto intitolarlo. Il mistero. Černobyl’ è un enigma che dobbiamo ancora decifrare. È forse un compito per il XXI secolo. Una sfida lanciata al nuovo secolo. Riguarda ciò che l’uomo ha appreso, intuito, scoperto a Černobyl’. Su se stesso e sul proprio atteggiamento nei confronti del mondo. La ricostruzione non degli avvenimenti, ma dei sentimenti.
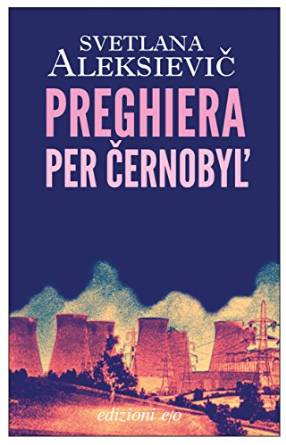 Sulla terra di Černobyl’, nella piccola Belarus’, di cui – prima che la catastrofe nucleare della primavera del 1986 la trasformasse in laboratorio dell’orrore – il mondo non aveva quasi sentito parlare, la bielorussa Svetlana Aleksievič, autrice fino ad allora di formidabili e scomodi reportage di guerra, smette di “scrutare” le sofferenze altrui per riconoscersi ella stessa testimone, “una in mezzo agli altri”.
Sulla terra di Černobyl’, nella piccola Belarus’, di cui – prima che la catastrofe nucleare della primavera del 1986 la trasformasse in laboratorio dell’orrore – il mondo non aveva quasi sentito parlare, la bielorussa Svetlana Aleksievič, autrice fino ad allora di formidabili e scomodi reportage di guerra, smette di “scrutare” le sofferenze altrui per riconoscersi ella stessa testimone, “una in mezzo agli altri”.
È da qui, dalla semplice constatazione che tra voce narrante e cosa narrata non c’è margine o possibile distanza, che ha origine un esperimento di scrittura e un’invenzione narrativa che vanno dritti al cuore e alla coscienza di chi legge. Quel dichiararsi dell’autrice parte del “popolo di Černobyl'” produce una sorta di vortice emotivo: d’ora in avanti le molteplici voci da lei raccolte, le infinite piccole storie di vita e di morte pazientemente registrate in tre anni di ricerca sul luogo del disastro, diventeranno la sua voce. Un abisso di dolore e di sgomento, la presa d’atto che a Černobyl’ è successo l’impensabile, qualcosa che la nostra lingua non è attrezzata a raccontare, che ha azzerato ogni nostro riferimento concettuale o schema interpretativo. Quel giorno, insieme al quarto reattore centrale, è esplosa per sempre la nostra familiarità col mondo, la possibilità di affidarsi alle percezioni corporee, di contare sui propri sensi. Più feroce e iniqua di una guerra, l’accadimento di Černobyl ha proiettato l’umanità in un tempo che non può più declinarsi al futuro e in uno spazio poroso e sfuggente, che non offre ripari o zone franche.
Dall’interno e dal basso
Come sporgersi in questa voragine a occhi ben aperti, senza difendersi dietro a tecnicismi e statistiche, senza consegnarsi allo schermo protettivo del ragionamento indiziario che cerca cause, colpe, responsabilità nell’illusione di dare un senso alle cose? Il metodo di Aleksievič ha del vertiginoso. È chiaro che non le interessano i dati e neppure le versioni ufficiali o le interpretazioni politiche. Ciò che la muove è la volontà di capire dall’interno e dal basso, come si sia riorganizzata la vita di chi, in pochi secondi, si è visto catapultare in un universo che neanche la letteratura fantascientifica più terminale aveva saputo anticipare.
Il suo strumento d’indagine è l’ascolto, la capacità di stare a lungo, indifesa e modesta, accanto a tante persone comuni – donne, uomini, vecchi, bambini – fino a guadagnarsene la fiducia e a ricostruire con loro, attraverso un amoroso esercizio di attenzione, quei dettagli che, assai meglio di qualsiasi teoria, sanno illuminare i processi della Storia. “Noi Černobyliani – le dice un insegnante di applicazioni tecniche – siamo spesso silenziosi. Non gridiamo e non ci lamentiamo. Sopportiamo, come sempre, sopportiamo. Anche perché non ci sono ancora le parole. Abbiamo timore ad affrontare questo argomento… Non sappiamo da che parte prenderlo… Un’esperienza insolita, questioni insolite… Il mondo si è diviso: ci siamo noi, quelli di Černobyl’, e ci siete voi, tutte le altre persone. Qui nessuno mette l’accento sulla nazionalità: io sono bielorusso, io ucraino, io russo. Si chiamano tutti Černobyliani, come se fosse un popolo a parte, una nuova nazione”.
Questo “popolo a parte”, cui il male assoluto ha fornito una cittadinanza inedita, è ora alla ricerca di un senso. Non per farsi una ragione di ciò che è accaduto, ma per non affondare nel caos totalitario della paura. Perché ad essere più disumana non è la morte o la sofferenza, bensì proprio la paura e i sentimenti terribili che essa produce. Paradossalmente, infatti, questa corale Preghiera per Černobyl’, che si interroga e interroga sul mistero del male, su ciò che non si può vedere né capire o descrivere se non attraverso la lente della pietas, è un formidabile testo sull’amore. Perché, come dice l’autrice, “la mia scrittura è un atto di protesta interiore: voglio restare un essere umano e non arrendermi all’enormità del male. Il lavoro dell’intellettuale è avvicinarsi sempre più alla realtà. Se però non si riesce a mettere a fuoco il senso di questa ricerca, ne viene fuori solo il magazzino degli orrori. Dobbiamo chiederci come liberare i nostri testi da ogni incrostazione emotiva, pur senza perdere la nostra individualità; come trasformare in arte, in parola, ciò che nella realtà ci ha fatti svenire. Descrivere lentamente la morte di un uomo non è estetizzarla, è dire che non è giusto morire così”.
Testimone del male, ma non da esso ipnotizzata, Aleksievič nega che la sofferenza sia erotica, là dove la piccola felicità sarebbe un sentimento senza storia e la bontà un bene in disuso.
Depositari di un contro-sapere non richiesto
“Dostoevskij diceva che solo la sofferenza fa di un uomo un uomo. Non sono d’accordo. In Georgia, sulle tombe, si inscrivono solo gli anni di felicità vissuti da un individuo”. In queste sue pagine sono le donne e i bambini, chi ha affetto per la vita e non si lascia incantare da miti eroici e militaristici, a sapere che il creato è un luogo dove esseri umani e animali, terra, acqua, aria, alberi e fiori, convivono in un equilibrio mirabile e delicato. La loro è la voce di chi, senza colpa, ha assistito all’irreparabile, diventando depositario di un contro-sapere aurorale e mortifero. Nella terra di nessuno che ora abitano, il linguaggio, il repertorio rassicurante delle parole che stanno a indicare le cose note e le persone care e ciò che adesso ci lega, si è disarticolato.
Di quale lingua servirsi, infatti, a quale sistema di segni ricorrere, se il medico che ha in cura la persona che più ami al mondo ti avverte: “Davanti a lei non c’è più suo marito, l’uomo che lei ama, ma un oggetto radioattivo con un alto potenziale di contaminazione”?. L’uomo ordinario, il piccolo uomo che ha un salario normale e va in ferie una volta l’anno, si è trasformato nell'”uomo di Černobyl'”: un uomo o una donna che “ha voglia di parlare di morte”.
A Nadotti è traduttrice e consulente editoriale
Negli ultimi mesi è stato rilevato dalle riviste scientifiche un ritorno della fauna selvatica nella “zona di esplosione” di Černobyl’. Federico Paolini ne parla in un articolo sul numero di gennaio 2016.



