Hollywood contro Wikipedia
di David William Ellwood
dal numero di gennaio 2016
Il “New York Times” del 13 novembre 2015 ha raccontato gli ultimi sviluppi nella saga senza fine dei Diari di Anna Frank. Uno dei bestseller del ventesimo secolo, i Diari dovevano uscire dal copyright il primo gennaio 2016, settant’anni dopo la morte dell’autrice, secondo lo standard più diffuso nell’ambito delle leggi di copyright. Diversi editori, produttori televisivi, studiosi ecc. si stavano preparando per sfruttare la scadenza. Ma negli ultimi tempi sarebbe saltata fuori una grossa complicazione: la fondazione svizzera che tiene i diritti, fondata dal padre della Frank, ha insistito che lui ha contribuito tanto alla creazione della edizione più nota dei Diari che deve essere riconosciuto come il co-autore, e poiché è morto nel 1980, il copyright scadrà non nel 2016 ma nel 2050. Non è così, replica invece il Museo Anne Frank di Amsterdam, che conserva i manoscritti originali, gli archivi e la casa, e sta preparando, con uno studioso tedesco, un’edizione filologicamente corretta dei diari che dovrebbe uscire online dopo il primo gennaio. Secondo gli olandesi, non esiste un co-autore. Il copyright non può durare per l’eternità, insistono; è loro dovere verso il pubblico favorire il più grande accesso possibile ai materiali. Di mezzo ci sono interessi finanziari – la Fondazione svizzera distribuisce i notevoli diritti di autore a una gamma di organizzazioni non governative e altre opere caritatevoli – ma anche le interpretazioni da dare alle leggi di copyright nei vari paesi coinvolti, compresa la Germania.
Si tratta di un caso esemplare delle due concezioni di fondo che hanno contraddistinto, e diviso, la questione dei diritti di autore fin da quando essa è stata posta seriamente per la prima volta più di trecento anni fa. Da una parte stanno quelli che difendono un’idea della produzione intellettuale come creazione di una forma di proprietà, altamente personale, a totale disposizione del creatore, e, eventualmente dei suoi eredi (da lì la regola dei settant’anni, un numero discusso a lungo e tuttora contestato in tanti ambiti diversi). Dall’altra parte ci sono i sostenitori della fruibilità, dell’accesso, della democratizzazione – tramite il mercato ma anche attraverso la scuola e tutti gli altri canali pubblici rilevanti – del consumo culturale. Oltre agli ovvi risvolti giuridici ed economici del confronto, sono sempre comparse nelle controversie delle inevitabili questioni morali: i democratici accusano i creatori di essere protezionisti egoisti, mentre gli scrittori, i musicisti, i pittori, i registi, o chi per loro, denunciano i primi come pirati, “cleptomani” e “parassiti” (le parole virgolettate sono state usate da Rupert Murdoch nei confronti di Google). La storia, naturalmente, fornisce prove in grande quantità per sostenere entrambe le posizioni.
La battaglia del copyright
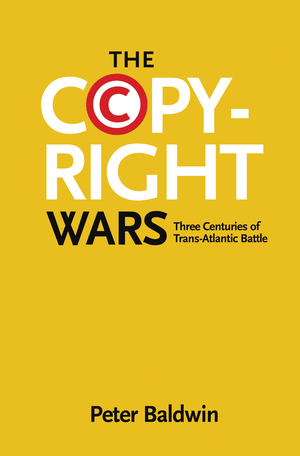 Il libro di Peter Baldwin, The Copyright Wars. Three Centuries of Trans-Atlantic Battle (Princeton University Press, 2014) offre una lettura completa e approfondita dell’evoluzione dei concetti di diritti d’autore e di copyright dietro i casi appena citati. Baldwin, che insegna alla New York University, porta un approccio storico-politico all’evolversi delle definizioni prevalentemente legali dei concetti di fondo. Al centro della sua visione stanno l’Europa e gli Stati Uniti. Dentro il mondo atlantico la battaglia per l’egemonia delle interpretazioni sarebbe andata avanti da almeno trecento anni e continua ogni giorno. Baldwin dimostra come la dialettica di fondo che condiziona l’evoluzione della questione è nata nella Francia del Settecento. Essa vede contrapposte quelle forze che difendono un’idea della produzione creativa come un processo personale che risulta in una forma di proprietà, in contrasto con tutte quelle istanze commerciali che la vedono come una realtà sì individuale ma che non potrebbe esistere senza un mercato, e comunque è parte del patrimonio culturale di tutta una società. L’autore non ha dubbi. Insistere in modo esclusivo e totalizzante sui diritti degli autori, compresi quelli morali che deriverebbero dall’opera come estensione della loro personalità e quindi inviolabili (anche dopo la loro morte), sarebbe elitario, esclusivo ed anti-democratico. Sarebbe tipico di una certa idea europea, e francese in particolare, della cultura alta. L’idea di copyright invece “dà agli autori un monopolio limitato (nel tempo e nello spazio) sulle proprie opere per stimolare la loro creatività, arricchire alla lunga la società civile, e in questo modo servire l’interesse del grande pubblico”. Il copyright quindi è una forma di compromesso tra quelli, autori e loro difensori ufficiali, che vogliono la proprietà intellettuale il più immobile possibile, e per periodi di tempo più lunghi possibili, e chi (editori, distributori, scuole e università, piattaforme informatiche) la vuole mobile, e per tempi brevi.
Il libro di Peter Baldwin, The Copyright Wars. Three Centuries of Trans-Atlantic Battle (Princeton University Press, 2014) offre una lettura completa e approfondita dell’evoluzione dei concetti di diritti d’autore e di copyright dietro i casi appena citati. Baldwin, che insegna alla New York University, porta un approccio storico-politico all’evolversi delle definizioni prevalentemente legali dei concetti di fondo. Al centro della sua visione stanno l’Europa e gli Stati Uniti. Dentro il mondo atlantico la battaglia per l’egemonia delle interpretazioni sarebbe andata avanti da almeno trecento anni e continua ogni giorno. Baldwin dimostra come la dialettica di fondo che condiziona l’evoluzione della questione è nata nella Francia del Settecento. Essa vede contrapposte quelle forze che difendono un’idea della produzione creativa come un processo personale che risulta in una forma di proprietà, in contrasto con tutte quelle istanze commerciali che la vedono come una realtà sì individuale ma che non potrebbe esistere senza un mercato, e comunque è parte del patrimonio culturale di tutta una società. L’autore non ha dubbi. Insistere in modo esclusivo e totalizzante sui diritti degli autori, compresi quelli morali che deriverebbero dall’opera come estensione della loro personalità e quindi inviolabili (anche dopo la loro morte), sarebbe elitario, esclusivo ed anti-democratico. Sarebbe tipico di una certa idea europea, e francese in particolare, della cultura alta. L’idea di copyright invece “dà agli autori un monopolio limitato (nel tempo e nello spazio) sulle proprie opere per stimolare la loro creatività, arricchire alla lunga la società civile, e in questo modo servire l’interesse del grande pubblico”. Il copyright quindi è una forma di compromesso tra quelli, autori e loro difensori ufficiali, che vogliono la proprietà intellettuale il più immobile possibile, e per periodi di tempo più lunghi possibili, e chi (editori, distributori, scuole e università, piattaforme informatiche) la vuole mobile, e per tempi brevi.
Europa e Stati Uniti: due visioni a confronto
La storia raccontata da Baldwin dimostra comunque che a vincere fino all’altro ieri sarebbero state le concezioni europee della supremazia dell’autore, trionfando alla lunga su quegli impulsi americani, nati dalla pirateria pura dell’Ottocento, che insistevano rumorosamente sulla democrazia dei mercati, e sulla scolarizzazione delle masse tramite edizioni a prezzi stracciati. Riconoscendo la supremazia e l’utilità dell’approccio europeo, e negli interessi delle loro immense copyright industries, nel 1989 gli Stati Uniti hanno finalmente aderito ai termini della Convenzione di Berna del 1886, lo statuto che per primo ha regolato e coordinato i diritti degli autori fuori dai loro paesi di origine, vivi o morti, e tuttora in vigore. Ma l’arrivo di internet ha sconvolto tutti gli equilibri, devastando le industrie musicali, cinematografiche e altre ancora, e dando alle masse planetarie la convinzione che l’accesso a tutta la produzione culturale del mondo, passato, presente e futuro, dovrebbe essere gratis, un inequivocabile diritto democratico. Qui gli interessi di Hollywood si contrappongono drammaticamente a quelli di Wikipedia, Google, Amazon ecc., e le loro battaglie si proiettano ben oltre i confini degli Stati Uniti. Con l’Europa il confronto è interminabile; con la pirateria aperta e tollerata ufficiosamente in Cina e Russia è ancora più serio, perché coinvolge i governi direttamente.
Baldwin parte dai concetti di base e dalle loro articolazioni, illustrate con un ricco affresco di casi giuridici dal Settecento ai giorni nostri per poi seguire una struttura cronologica e arrivare all’attualità. Un capitolo a parte è dedicato alla peculiare spinta all’idea di diritti morali data dai regimi nazista e fascista (l’autore ci ricorda che la base giuridica del sistema di diritti d’autore tuttora prevalente in Italia è di origine fascista). Dopo la seconda guerra mondiale la Francia avrebbe dato la sua impronta protezionista a tutta la prospettiva della Comunità europea sull’argomento, e poco a poco gli americani si sarebbero adeguati. Nel mondo post-moderno e digitale, gli utopisti proclamano la fine della distinzione tra autore e consumatore, ma non è così semplice, scrive Baldwin. Come nel passato, ogni creatore o fornitore di contenuti avrà le sue pretese, economiche, giuridiche e culturali. Davanti alla ricerca perpetua di un equilibrio tra produttore e pubblico, Baldwin indubbiamente favorisce il democratico approccio americano, e a volte esprime in modo sprezzante e ripetitivo la sua valutazione negativa sui protezionisti europei. Ma col suo lavoro negli archivi giuridici e parlamentari di Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti e Comunità europea, oltre ad una vasta lettura di fonti di epoca, ha acquisito un’autorevolezza sull’argomento incontestabile.
Copyright e industria culturale
Ormai la questione dei diritti degli autori e del copyright si è allargata ben oltre i casi classici dei testi scritti, della musica, delle immagini fisse o in movimento. Il concetto di proprietà intellettuale include questi ma anche i brevetti, i disegni tecnici e scientifici, i marchi di beni e di servizi. Non a caso, l’unico accordo firmato dalla Cina e dagli Stati Uniti durante l’ultima visita del capo del governo cinese Xi Jinping a Washington riguardava la proprietà intellettuale. La Cina ha visto negli anni passati la crescita di una vasta industria culturale basata più spesso che non sulla pirateria, con Hollywood il primo dei copyright industries americani a protestare per le conseguenze. La logica dell’analisi di Baldwin suggerisce che quando una nazione comincia a passare consapevolmente dal consumo alla produzione di contenuti culturali, prima o poi si trasforma da pirata a protezionista.
Di sicuro, è in Asia che si vedranno in futuro le più importanti battaglie politiche su questi problemi. Il patto per la liberalizzazione dei commerci nella zona del Pacifico (Trans-Pacific Partnership o Tpp) – che non include la Cina – contiene un capitolo molto in evidenza dedicato alla proprietà intellettuale. C’è chi vi vede un attacco fondamentale alla libertà e alla natura gratuita di internet, poiché il patto prevede un sforzo molto imponente per far rispettare davvero le leggi del copyright. Un commentatore sul “Guardian Weekly” inglese, condannando la regola dei settant’anni come fosse una novità, scrive: ‘Ciò potrebbe significare tenere chiusa sotto chiave una quantità immisurabile di informazioni, arte e creatività”. Solo chi non è disposto a pagare i diritti o ottenere una licenza potrebbe scrivere una frase del genere. Dopo il libro di Baldwin, nessuno può pensare davvero che un accordo commerciale come il Tpp minacci la sopravvivenza stessa di internet, come denuncia il “Guardian Weekly”. La storia dei rapporti trans-atlantici in ambito culturale dimostra che una certa dialettica ci sarà sempre tra creatori e fruitori, anche aspra, ma anche che ci sono mille modi per raggiungere un modus vivendi.
davidwilliam.ellwood@unibo.it
D W Ellwood insegna relazioni internazionali all’Università di Bologna Johns Hopkinns



