“Mi piace Machiavelli pecché te ‘mpara a cummannà”
di Antonio R. Daniele
dal numero di febbraio 2017
In un noto saggio di alcuni anni fa, Alberto Casadei ci spiegò che il successo di Gomorra, a differenza di altri libri sulla camorra o sulla malavita che pure erano già stati pubblicati ma non avevano ottenuto lo stesso riscontro, stava soprattutto nella simbiosi fra testo e autore: quel libro non sarebbe diventato un best-seller, non avrebbe segnato un’epoca, se Saviano non ne avesse condiviso una specie di compromissione ambientale. E questa compromissione avrebbe favorito il sorgere di un nuovo “naturalismo”. La sua lettura non persuase tutti. Non c’è dubbio che la profonda conoscenza dei fatti e il piglio del suo autore, che si è presentato al lettore quasi come un ragazzo fra i ragazzi, hanno attratto il pubblico come può farlo una figura che si attaglia alla struttura mentale degli uomini che ci racconta ma per svelarne i più arcani e i più spietati sistemi di vita. Egli ebbe, insomma, il profilo di qualcosa che si avvicinava molto a un survivor: un prode che della sua terra non conosce soltanto i segreti del crimine, ma ne può fare soprattutto la cronaca “antropologica”, restituendoci requisiti e connotati di un fattore umano che in premessa ci veniva dato come estraneo al nostro modo di pensare e di regolare i tempi della nostra vita. Ma il lettore di Gomorra – il lettore di Saviano – è stato anzitutto l’homo televisivus, ancora capace di subire un piccolo sussulto emotivo alla lettura di “crepare”, con tutta l’armonia della sintesi icastica della delinquenza imposta dalla narrazione sul piccolo schermo: “crepare a quindici anni in questa periferia sembra scontare una condanna a morte piuttosto che essere privati della vita”; “ma a crepare non sono solo mafiosi. Fuori della fabbrica c’era una foto appesa su una porta”; “crepare per un proiettile di rimbalzo sputato da un mitra lanciato dal tredicesimo piano è un’ipotesi che non si prende in considerazione”; “riempii i miei pomeriggi cercando di ipotizzare cosa avesse in mente prima di crepare”. E via di questo passo.
Ma a questa soluzione da cattivismo catodico e, più di tutto, hollywoodiano, Saviano ha abilmente alternato il lessico e il tono ambientale della scrittura mafiosa più tradizionale, sia ripescandola dalla nostra archeologia letteraria (Sciascia) sia mutuandola dall’altrettanto pervasiva “funzione mediale” di Camilleri: i “morti ammazzati” conservano nelle pagine della cronaca e del racconto un sapore di materica e torbida truculenza al cui godimento non sappiamo rinunciare. Tuttavia, non fu questo a fare di Saviano e delle sue pagine un evento, qualcosa che si è prodotto e si produce in una serie più o meno precisa di cause e di effetti. In prima istanza fu, invece, l’introduzione di un liber œconomicus fra un morto e l’altro. Ma anche l’irruzione prepotente di “fatturato”, “affari” e di tutta quella costellazione verbale che cresce attorno alla chioccia del mostro scultoreo che ci hanno disegnato nella mente e che chiamano “Sistema”, non avvenne in un terreno del tutto vergine, sempre restando sul piano strettamente mediatico, quello sul quale è fiorito tutto il fenomeno: gli intrecci fra lo Stato e le mafie sono un motivo giornalistico ricorrente almeno dal Marco Travaglio dell’Odore dei soldi (2001) e degli Intoccabili (2005), e dalla risonante eco delle sue inchieste per la tribuna di Santoro negli anni del picco berlusconiano. Così, l’ambizione alla “legalità”, avidamente masticata in quegli anni, ha dissodato il terreno e, in una certa misura, lo ha preparato: il lettore neopopolare era pronto a soddisfare una atavica fame di giustizia mescolando l’indignazione del cittadino frodato dal Sistema alla smania di corrispondenti storie di sangue e di morte. Certo, se volessimo risalire più indietro, potremmo chiamare in causa Il boss è solo di Enzo Biagi (1986), il primo resoconto sulla mafia con la patente del “vero”, ma si trattava di un giornalismo al limite della sindrome di Stoccolma. Con Saviano siamo passati per la prima volta dallo scrittore “intorno a”, allo scrittore e al narratore nettamente “anti” il crimine di cui egli stesso è testimone.

Roberto Saviano durante la sua partecipazione alla trasmissione Di martedì – La7
La poetica della realtà in Saviano
Eppure quella di Gomorra fu una scrittura avvertita e consapevole ma oculatamente impastata a una sintesi di cultura letteraria; fu la sublimazione del dato numerico, del “documento” nella sua accezione investigativa: un registro contabile narrato. Fu, dunque, una economia del potere ammannita come vivanda plebea. E le citazioni in esergo ce lo rivelano: dal saggio storico-etico al cult-movie passando per Machiavelli, al solito vestito cogli abiti stretti del teorico della politica contemporanea, e quindi, come si vuole, modernissimo e popolare. E, naturalmente, il passo che Saviano ha espunto da Le origini del totalitarismo di Hannah Arendt è una parafrasi del testo vero e proprio, più articolato e pregno; una versione per il lettore medio ma con una fatale deminutio: è chiaro che il «comprendere cosa significa l’atroce» riportato da Saviano non vale il «comprendere non significa negare l’atroce» della filosofa tedesca. Ma chi lo avrebbe rilevato? Molto di più contava notare che quelle parole collocate in epigrafe – cioè piantate quasi letteralmente come una lapide verbale nella terra delle scritture italiane degli Anni Zero – preludevano alla “poetica della realtà” del libro. D’altronde, come tutte le poetiche, anche quella di Saviano era destinata ad assumere i tratti della maniera, una retorica dello stile che ha saputo fare della ricerca atteggiata una vera estetica della “responsabilità autoriale”. Il primato della parola, la sua forza etico-sociale, sono il connotato che lo scrittore napoletano ha avocato a sé col fiducioso convincimento di poterne essere l’interprete migliore. La letteratura è, prima di tutto, parola; e, anche nelle sue manifestazioni più spensierate, essa denuncia il male. La letteratura, però, non si incarica di trovarvi il rimedio, contentandosi della denuncia medesima come “atto culturale”.
A Saviano tutto questo non bastò. Gomorra è una scrittura documentale di marca espressionista e per questo votata a generare “ascolti”: «i boss che decidono di non pentirsi vivono di un potere metafisico»; «la carica letale di certa mitologia violenta»; le «mitologie d’imitazione»; «il codice sibillino dell’ammiccamento». La formula ha funzionato in pieno proprio perché lo scrittore non è veramente figlio di quel mondo con cui vuole “compromettersi” sul piano ambientale, né noi, sul piano mentale, siamo davvero intimamente estranei a quello stesso mondo. Saviano ha saputo stanare la pruderie del lettore di fronte alla conoscenza dei congegni affaristici dei mafiosi e da allora questo fiducioso consumatore di documenti raccontati – un pubblico la cui cultura estetico-stilistico-lessico-letteraria aveva bisogno di una autenticazione definitiva – ha preso a giudicare il malaffare criminale un fattore ordinario del sistema Italia, consolandosi al tempo stesso col miraggio della “legalità”, termine che di anno in anno è apparso un mantra rassicurante. Il libro non è più nemmeno una forma ibrida, come pure è sembrato per un certo tempo. In fondo, Gomorra non è più nemmeno il libro. E ha cominciato a esserlo sempre meno dall’autunno del 2006, pochi mesi dopo l’uscita, quando al suo autore fu assegnata la scorta. Da quel momento prese corpo il paradosso più grosso: Roberto Saviano fu proprio quel personaggio del reality che, come egli stesso scrisse, aveva sempre rifiutato di fare. «Sognavano di far derivare da Scampia una puntata di un reality»: fu questo l’ “atto culturale” che sortì dal libro (una Hollywood su carta che “ti tocca essere fino in fondo”, come in uno dei sintagmi da cineteca che si leggono tra le pagine) e così, la compromissione ambientale rese Saviano stesso un pezzo di Scampia in un “reality permanente”, ovverosia non un testimone in perpetuum, ma uno stabile “fattore mediatico”, un martire vivente ed esposto alla maniera delle icone russe. Gomorra è un dilatamento della lettera nella figura mediatica del suo autore, la fata morgana che garantisce allo spettatore il prolungamento di una disfida etica: la legalità come attesa messianica. Nulla di sorprendente: Saviano verrebbe ad essere l’ultimo capo della “linea dell’intellettuale” tracciata da Pierluigi Pellini un paio di anni fa. Da Zola, appunto, a Saviano: così si rigenera l’attore pubblico collettivo, come dalle parole del critico. Ma quella tenue patina classicheggiante è del tutto evaporata e “attore”, come si vede, non è che una questione di show. Eppure il libro possedeva in germe tutto quanto occorreva a generare l’ “effetto Saviano”. Il nostro scrittore ha rivendicato le ascendenze capotiane, passando tuttavia dalla terza persona del modello alla tracimante prima persona del suo lavoro più noto: bisognava dare del tu al lettore. Questa energica disponibilità doveva avere la forza di tradurre un’arida successione di fatti e di nomi in un assolo drammatico, qualche volta anche fraterno e pedagogico, che sottraeva però un elemento decisivo: la possibilità del bene.
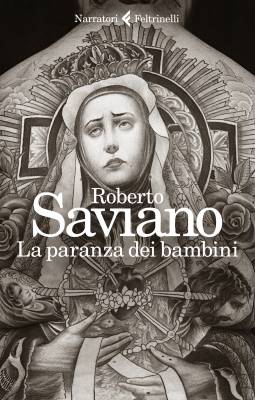 Lo vediamo oggi con La paranza dei bambini, un irresoluto tentativo, a dieci anni di distanza, di rientrare nella “forma romanzo” per mezzo di una giovane banda mafiosa; qualcosa a metà strada fra De Cataldo e De Silva, un romanzo criminale dei bambini, dove però il bene è del tutto esterno alla storia e ai suoi personaggi: la speranza della legalità è infine utopia. La parola ha chiuso la propria parabola: scritta, visualizzata e predicata per mezzo del suo stesso autore, ha assunto i tratti del mito e ora finisce per cristallizzare tutto ciò che racconta. E il Machiavelli di Gomorra, da convitato di pietra, è quasi un elemento della narrazione, il sigillo letterario di una scelta di vita: “mi piace Machiavelli pecche te ‘mpara a cummannà” dice Nicolas, il ragazzino protagonista di quest’ultimo libro; poi, nella breve sezione che ha titolo “Il Principe”, Nicolas parafrasa il diciassettesimo capitolo del libello del Segretario: “se il Principe tiene un esercito, quell’esercito deve ricordare a tutti che lui è uomo terribile, terribile, perché sennò un esercito non lo tieni unito se non sai farti temere”. Machiavelli e il suo Principe sono una auctoritas coi connotati dell’erma bifronte: messi in bocca al mafioso, ne riescono distorti sulla base della tradizionale semplificazione dell’infallibile prontuario del potere; amministrati dall’intellettuale, che a quella bocca dà voce, si riabilitano: circa un anno fa Saviano stesso rispolverò il trattatello sui principati per arringare contro gli oppositori di Schengen: “costruire nuovi castelli genera solo nuovi assedi” (“La Repubblica”, 15 febbraio 2016), potente ma eccessiva sinossi del capitolo X. Qualche volta le due funzioni si sono sovrapposte con esiti pressoché grotteschi come nell’ultima puntata di Vieni via con me (2010), dove Dario Fo, fra un monologo di Saviano e l’altro, lesse i cinque consigli che Machiavelli dava al Principe: c’è da credere che ancora oggi il pubblico di quella sera non sappia che Machiavelli mai scrisse quelle “cinque cose” e, quindi, che Fo non lesse dal Principe, né lo riscrisse, ma, fedelissimo alla sua arte, gli fece il verso e lo applicò a Berlusconi, riscrivendo – stavolta sì – e ampliando un testo dell’estate del 2002 scritto col figlio e con Franca Rame. Ma l’internauta lettore-spettatore di Saviano vedrà la performance su YouTube e in calce vi leggerà “Dario Fo recita Machiavelli”, con l’immancabile corollario sulla retorica dell’“attualità del Principe” da fonti web anche non proprio peregrine. In fondo quando nel 1992 Silvio Berlusconi, emulando Craxi e il Duce, scrisse un saggio per una stramba edizione del trattato e, a motivo di quelle storiche pagine, vi trovava la ricetta per reggere e disporre dello Stato dopo Tangentopoli, inaugurò la dialettica machiavellesca che porta dritta a Gomorra, iuxta Fo (e Travaglio). E la natura sentenziosa del motto che Mussolini a suo tempo aveva ricavato da Machiavelli (“cum parole non si mantengono li Stati”), si riconnette a uno dei tanti apologhi sul “chi comanda” che agisce in controluce come testo secondo: “c’è chi comanda le parole e chi comanda le cose. Tu devi capire chi comanda le cose, e fingere di credere a chi comanda le parole”. Ma neppure il segretario fiorentino e i suoi epifonemi furono una novità nelle narrazioni di mafia e questa voga si rintraccia in un paio di passaggi già nel Romanzo criminale (2002) di De Cataldo: “l’omini che te rompono li cojoni o se comprano o se spengono”, esclama Dandi citando a braccio, in una nuova versione della “esperienzia delle cose moderne”.
Lo vediamo oggi con La paranza dei bambini, un irresoluto tentativo, a dieci anni di distanza, di rientrare nella “forma romanzo” per mezzo di una giovane banda mafiosa; qualcosa a metà strada fra De Cataldo e De Silva, un romanzo criminale dei bambini, dove però il bene è del tutto esterno alla storia e ai suoi personaggi: la speranza della legalità è infine utopia. La parola ha chiuso la propria parabola: scritta, visualizzata e predicata per mezzo del suo stesso autore, ha assunto i tratti del mito e ora finisce per cristallizzare tutto ciò che racconta. E il Machiavelli di Gomorra, da convitato di pietra, è quasi un elemento della narrazione, il sigillo letterario di una scelta di vita: “mi piace Machiavelli pecche te ‘mpara a cummannà” dice Nicolas, il ragazzino protagonista di quest’ultimo libro; poi, nella breve sezione che ha titolo “Il Principe”, Nicolas parafrasa il diciassettesimo capitolo del libello del Segretario: “se il Principe tiene un esercito, quell’esercito deve ricordare a tutti che lui è uomo terribile, terribile, perché sennò un esercito non lo tieni unito se non sai farti temere”. Machiavelli e il suo Principe sono una auctoritas coi connotati dell’erma bifronte: messi in bocca al mafioso, ne riescono distorti sulla base della tradizionale semplificazione dell’infallibile prontuario del potere; amministrati dall’intellettuale, che a quella bocca dà voce, si riabilitano: circa un anno fa Saviano stesso rispolverò il trattatello sui principati per arringare contro gli oppositori di Schengen: “costruire nuovi castelli genera solo nuovi assedi” (“La Repubblica”, 15 febbraio 2016), potente ma eccessiva sinossi del capitolo X. Qualche volta le due funzioni si sono sovrapposte con esiti pressoché grotteschi come nell’ultima puntata di Vieni via con me (2010), dove Dario Fo, fra un monologo di Saviano e l’altro, lesse i cinque consigli che Machiavelli dava al Principe: c’è da credere che ancora oggi il pubblico di quella sera non sappia che Machiavelli mai scrisse quelle “cinque cose” e, quindi, che Fo non lesse dal Principe, né lo riscrisse, ma, fedelissimo alla sua arte, gli fece il verso e lo applicò a Berlusconi, riscrivendo – stavolta sì – e ampliando un testo dell’estate del 2002 scritto col figlio e con Franca Rame. Ma l’internauta lettore-spettatore di Saviano vedrà la performance su YouTube e in calce vi leggerà “Dario Fo recita Machiavelli”, con l’immancabile corollario sulla retorica dell’“attualità del Principe” da fonti web anche non proprio peregrine. In fondo quando nel 1992 Silvio Berlusconi, emulando Craxi e il Duce, scrisse un saggio per una stramba edizione del trattato e, a motivo di quelle storiche pagine, vi trovava la ricetta per reggere e disporre dello Stato dopo Tangentopoli, inaugurò la dialettica machiavellesca che porta dritta a Gomorra, iuxta Fo (e Travaglio). E la natura sentenziosa del motto che Mussolini a suo tempo aveva ricavato da Machiavelli (“cum parole non si mantengono li Stati”), si riconnette a uno dei tanti apologhi sul “chi comanda” che agisce in controluce come testo secondo: “c’è chi comanda le parole e chi comanda le cose. Tu devi capire chi comanda le cose, e fingere di credere a chi comanda le parole”. Ma neppure il segretario fiorentino e i suoi epifonemi furono una novità nelle narrazioni di mafia e questa voga si rintraccia in un paio di passaggi già nel Romanzo criminale (2002) di De Cataldo: “l’omini che te rompono li cojoni o se comprano o se spengono”, esclama Dandi citando a braccio, in una nuova versione della “esperienzia delle cose moderne”.
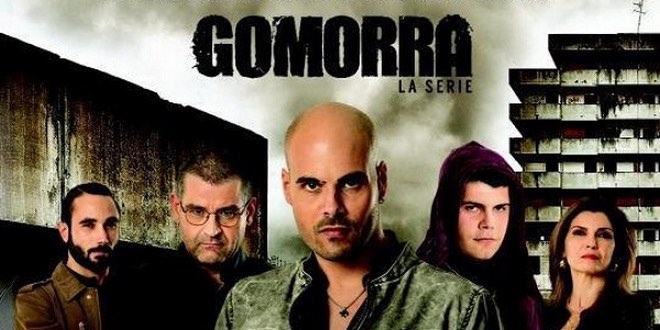
“Nel Paese di Pirandello e di Machiavelli”, scriveva ancora De Cataldo, sorge facilmente un “coté letterario. Il verosimile, l’apparente ma non il vero”. Così, dopo l’inevitabile ma bellissimo film di Garrone, ecco in qualche anno tutta la parabola della “rappresentabilità”, inclusa la parodia, momento nel quale il modello si consacra del tutto: Fortapàsc di Marco Risi (2009), benché trattasse la stessa storia, non veniva da L’abusivo di Franchini, a quel punto fonte non più competitiva, ma operava sulla base dell’ “epica gomorresca”; e Mozzarella stories (2011) di Edoardo De Angelis glorificò “ ‘o ciato ‘e bbufala” del caglio e dei suoi affari che già Saviano aveva raccontato nel suo libro. Con uno scambio di volti, di ghigni, di sagome e armonie vocali da Gianfelice Imparato a Salvatore Cantalupo; da Salvatore Striano a Massimiliano Gallo a Toni Laudadio: un cast remixed, una piccola “cosca cinematografica” che da set a set doveva restituisci lo stesso miasma. Fino alla serie Sky e al pubblico fan; o, come si scrive ormai nelle pagine di certi studi specialistici, grassroot.
Nel novembre del 1989 Alberto Moravia, deputato al Parlamento Europeo, scrivendo un pezzo per il “Corriere” sul fallito golpe di Giroldi ai danni del dittatore di Panama Noriega, incominciò curiosamente dalla machiavelliana Descrizione del modo tenuto dal duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il duca di Gravina Orsini, perché certe esuberanze della politica latinoamericana parevano molto mediterranee e d’altronde – scrisse Moravia – “la retorica umanistica ammanta di bellissima prosa volgari figure di criminali non tanto diversi nei mezzi e nei fini dagli attuali capi delle varie mafie dell’Italia di oggi”. Precisando che “le mafie lottano per il denaro prima ancora che per il potere, il quale, in tutti i casi, non potrà che essere occulto e inconfessabile”, lo scrittore romano ci spiegò che il golpista Giroldi era della stessa pasta di Vitellozzo e Oliverotto che volevano rovesciare il loro nemico per smania di autoritarismo e crudeltà. Dei boss del Rinascimento, insomma. L’articolo procedeva poi per altre vie, ma nelle sue prime righe si leggeva di questa attitudine che si propaga fra uomini di certe latitudini o culture e passata alla storia sotto il nome di “machiavellismo”: essa in origine non era che un insieme di “ristrette e anarchiche ambizioni personali” tutte interne al suo autore. Parole che, in verità, si legano al noto saggio su Machiavelli che Moravia compose mentre fuggiva a Fondi nelle settimane della rappresaglia nazista, dove dimostrò con acume che il Principe fu nient’altro che uno strumento letterario nato per appagare “uno spasmodico desiderio di vita espresso in consapevole crudeltà”. Machiavelli amò la patria e ne desiderò la salvezza, ma ancor di più desiderava sussistere, “voltolare un sasso”. “Donde – concluse Moravia – il carattere esplosivo, lirico, perentorio del Principe”. Quel carattere che ha trasudato nei decenni la propria forza d’espressione, ha concretato non solo e non tanto la dottrina che illustrava ma l’energia di vita, la brama “di esserci” dell’autore medesimo. Ecco che il nuovo, ma vecchissimo, “principio machiavellico” che si staglia da Saviano e dai suoi libri, fino a La paranza dei bambini nel quale la mimesi e, vorrei dire, la nemesi è completa, non è che questo genetico, italico ardore di persistenza nelle cose, nei fatti. Come in Machiavelli – scrisse Moravia – “la necessità di non affogare nell’indifferenza, lo spinge a ferirsi a morte pur di sentirsi vivo”, così in Roberto Saviano l’urgenza della passione civile ha richiesto, e tuttora richiede, non solo una ipertrofia della parola ma anche una ambigua e tormentata sovraesposizione della figura.
Ma ancora Moravia, da una lontana recensione del Galileo di Liliana Cavani, potrebbe dissipare anche questa ombra residua: “a lui accadde un poco lo stesso che a Machiavelli: di essere quasi altrettanto affezionato al vecchio mondo che contribuisce a distruggere che al nuovo che si affatica a costruire”.
antonio.daniele@unifg.it
A R Daniele è dottore di ricerca in Italianistica all’Università di Foggia


