Un grande sceneggiatore vittoriano
di Franco Pezzini
dal numero di marzo 2016
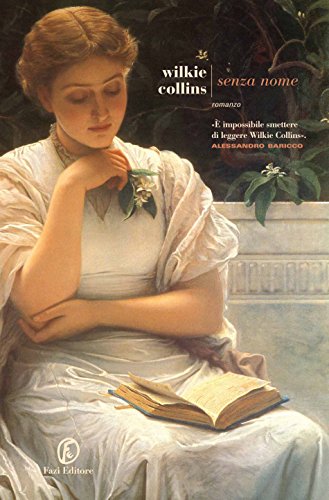 Pochi romanzieri di età vittoriana possono vantare l’eleganza di Wilkie Collins (1824-1889), uno dei padri riconosciuti del poliziesco, ma capace di strabordare da ogni steccato di genere con la sua prosa autenticamente letteraria. Una qualità di scrittura a monte della stima – presto coniugata a un’amicizia profonda – che gli riconosce il mattatore Charles Dickens; e se la produzione più tarda sarà ostacolata dalle cattive condizioni di salute, le opere principali hanno a quel punto già riconosciuto a Collins una fama internazionale.
Pochi romanzieri di età vittoriana possono vantare l’eleganza di Wilkie Collins (1824-1889), uno dei padri riconosciuti del poliziesco, ma capace di strabordare da ogni steccato di genere con la sua prosa autenticamente letteraria. Una qualità di scrittura a monte della stima – presto coniugata a un’amicizia profonda – che gli riconosce il mattatore Charles Dickens; e se la produzione più tarda sarà ostacolata dalle cattive condizioni di salute, le opere principali hanno a quel punto già riconosciuto a Collins una fama internazionale.
Basti confrontarsi con i suoi dialoghi vivaci e intensi, psicologicamente tanto ricchi, capaci di stillare ironia o di traghettare nel dramma ma con senso assoluto della misura. Certo Collins guarda al teatro (per cui anche scriverà), e non a caso in prosieguo cinema e televisione saccheggeranno i suoi romanzi; ma il riferimento a una felicità “cinematografica” di sceneggiatura – come oggi comunemente intesa a proposito di autori dell’Ottocento – non dovrebbe oscurare nel suo caso due caratteristiche fondamentali.
Da un lato infatti lo sguardo narrante è – per così dire – quello del pittore, e il respiro lungo dei romanzi di Collins (figlio non a caso di un paesaggista) è quello che possiamo concederci nell’accostare un’ampia galleria di dipinti: una produzione romantica d’epoca su scorci di campagna, barbagli lunari su trasognate marine o cimiteri, sale di ville con finestre su giardini, incontri al crepuscolo tra ombre urbane velate, a far interagire i personaggi con un ambiente che già “parla”. Dove il senso d’attesa di testi apparsi a puntate, a incalzare i lettori, non si consuma mai nel gioco facile a suon di colpi di scena; ma è costruito poco per volta anche attraverso questa dimensione ambientale, pur sommessa e mai ostentata in eccessi descrittivi.
D’altro canto Collins occhieggia ai rovelli interiori dei suoi personaggi, ne percorre i dedali accidentati e costringe il lettore a palpitare non solo ai ritmi più ovvi della suspense, ma per intere nottate silenziose di dubbi ed eccitazioni, o per quelle strane impennate di umori e timori i cui motivi riesce però a partecipare attraverso finissime analisi psicologiche: fino a radici più profonde, alla vertigine – per così dire – delle opzioni fondamentali e al brivido del Male. Dove però la capacità di scrutare nell’animo “in verticale” non priva di una lettura accorta e sorniona dell’“orizzontale”: quelle riflessioni cioè di critica sociale che rendono impossibile estinguere il senso di tali romanzi (editi a puntate su riviste, e di successo popolarissimo) nel puro intrattenimento.
Crisi di identità a sfondo gotico
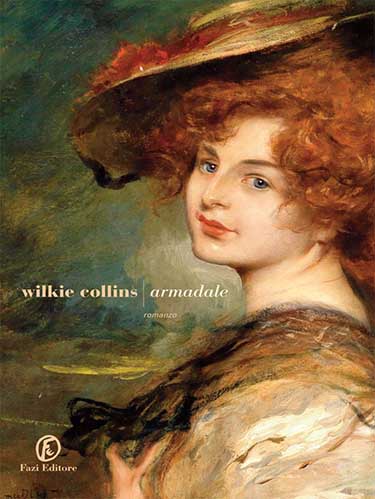 Meritoria dunque, da parte della romana Fazi, la riproposta negli anni in Italia di una parte importante dei suoi scritti: La pietra di Luna e La Legge e la Signora (entrambi 2000), Il fiume della colpa e Basil (2002), La veste nera (2003), Uomo e donna (2004), Foglie cadute (2005), più di recente La donna in bianco (2015), Senza nome (2015) e in ultimo Armadale (2016). Storie in gran parte “poliziesche”, nel senso però più ampio della cosiddetta sensation novel che vi combina elementi di mistero interiore, di tortuosi grovigli di sentimenti e drammi (o melodrammi) etici con misure variabili di gotico, e particolarmente giocate sul tema dell’identità. Per restare agli ultimi titoli proposti da Fazi, così avviene nel grande The Woman in White, 1859-60, considerato il primo mystery in senso moderno, con lo scambio d’identità tra la mentalmente instabile Anne Catherick e la sosia ereditiera Laura Fairlie; come anche in Armadale, 1866, coi quattro personaggi che associano tutti il nome Allan al cognome del titolo.
Meritoria dunque, da parte della romana Fazi, la riproposta negli anni in Italia di una parte importante dei suoi scritti: La pietra di Luna e La Legge e la Signora (entrambi 2000), Il fiume della colpa e Basil (2002), La veste nera (2003), Uomo e donna (2004), Foglie cadute (2005), più di recente La donna in bianco (2015), Senza nome (2015) e in ultimo Armadale (2016). Storie in gran parte “poliziesche”, nel senso però più ampio della cosiddetta sensation novel che vi combina elementi di mistero interiore, di tortuosi grovigli di sentimenti e drammi (o melodrammi) etici con misure variabili di gotico, e particolarmente giocate sul tema dell’identità. Per restare agli ultimi titoli proposti da Fazi, così avviene nel grande The Woman in White, 1859-60, considerato il primo mystery in senso moderno, con lo scambio d’identità tra la mentalmente instabile Anne Catherick e la sosia ereditiera Laura Fairlie; come anche in Armadale, 1866, coi quattro personaggi che associano tutti il nome Allan al cognome del titolo.
E così avviene emblematicamente – e ancora fin dal titolo – in No Name, 1862, un romanzo scintillante che può considerarsi tra le prove migliori di Collins, per quanto in Italia forse meno noto, e meno direttamente ascrivibile alla categoria poliziesca. Pubblicato all’inizio a puntate sulla rivista di Dickens “All the Year Round”, Senza nome (trad. dall’inglese di Luca Scarlini, pp. 806, € 18.50) declina proprio l’ossessione identitaria delle sensation novel – di volta in volta evocata in romanzi del tempo in termini simbolici, fantastici, melodrammatici – sul piano più diretto e concreto, quello delle ansie sociali.
Seconda metà degli anni quaranta: quando il pacioso gentiluomo Andrew Vanstone muore in un incidente di treno, e quasi contemporaneamente si spegne la moglie, le due figlie scoprono con orrore di essere “senza nome”, “Figlie di Nessuno” da un punto di vista successorio, perché il matrimonio tardivamente formalizzato tra i genitori era posteriore alle disposizioni testamentarie del padre. Tutti i beni, per la legge del tempo, devono dunque andare all’odioso zio: e Collins, che non solo non risparmia critiche nei suoi scritti all’istituzione matrimoniale ma non si sposa mai in modo formale (ha una compagna, la vedova Caroline Graves, e un rapporto con Martha Rudd che gli darà tre figli), affronta il tema con partecipazione.

Una scena dal film The Woman in White (1997)
Le reazioni delle due ragazze di fronte a quella crisi spaventosa quanto improvvisa saranno molto diverse. Come nelle due coppie generazionali (padri e figli) di Allan Armadale nell’omonimo romanzo, o nelle coppie di ragazze opposte in The Woman in White – la bella, fragile Laura e la tragica sosia Anne da un canto, dall’altro Laura stessa e la sorellastra Marian Halcombe, non avvenente ma umanamente incantevole –, Collins muove su modelli polari: il gioco è quello speculare caro all’età vittoriana e che in autori come lui e Le Fanu (pure del giro di Dickens, e ossessionato da doppi e raddoppiamenti) trova canonizzazioni fondamentali. In No Name, alla timida Norah si contrappone così la sorella Magdalen, all’inizio della storia svagata diciottenne dall’incontenibile esuberanza, ma poi irrigidita in inquieta vindice dei diritti che una legge assurda non riconosce. Oltretutto l’accaduto ha gelato nell’incertezza e in un penoso rinvio il suo sogno d’amore per un giovanotto, Frank Clare (peraltro di inarrivabile nullità); e se Norah, con l’appoggio della governante Miss Garth, si prepara ad affrontare con vittoriana pazienza e compostezza un futuro di marginalità, Magdalen fugge. Troverà un efficace alleato in un mezzo parente, il capitano Horatio Wragge, “agricoltore morale”, cioè truffatore professionista, con l’improbabile e candida moglie Matilda, una gigantessa da circo felliniano.
Amour fou per il teatro
L’amore di Collins per il teatro emerge fin dalla struttura del testo, per l’alternanza a otto capitoli narrativi chiamati “scene” di inserti (“Tra le scene”) epistolari: ed è proprio sviluppando le già testate doti di attrice (altro motivo classico di inquietudini vittoriane, la donna che finge, recita, “mente”) che Magdalen cerca di avvicinare il ramo della famiglia che ha predato la proprietà. Ma lo zio – una figura di ipocrita bacchettone attraverso cui Collins conduce il suo attacco a certo moralismo predatorio, e resta fuori scena come un’astrazione o un cattivo fantasma – muore all’improvviso. I beni passano dunque a un figlio malaticcio suo doppio e caricatura (nonché sorta di doppione dello sgradevole Frederick Fairlie, zio di Laura in The Woman in White): ed è questo cugino Noel che Magdalen provvede ad abbindolare, sposandolo sotto falsa identità per recuperare i beni. Le cose – anche a non voler raccontare tutto, onde non togliere il piacere della lettura – non andranno tanto lisce per la presenza di un’altra grande figura femminile, stavolta come vilain, la machiavellica Mrs. Lecount governante di Noel: Magdalen dovrà lottare ancora, interpretare altre parti, arrivare a meditare il suicidio.
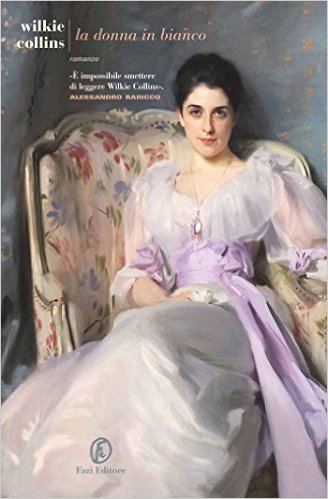 Certo, una lettura tradizionalista può apprezzare la premiata virtù della perfettina Norah, l’affetto coriaceo e profondo di Miss Garth e la serietà professionale con cui l’avvocato Pendril ha cercato (invano) di far ragionare lo zio delle ragazze; ma la desolazione e l’allarme che un po’ tutti mostrano alla rabbia di Magdalen restano in definitiva ancora espressioni del mondo che quegli orrori giuridici e sociali accetta. La società non può riconoscere legittimità alla sua ribellione e il fiato del Male è vicino, ma non ci sono dubbi su chi riceva la solidarietà dell’autore; e persino il capitano Wragge si guadagna un’affettuosa simpatia dei lettori (impagabili le sue avventure ultime, emblematiche di vicende commerciali mai tramontate). Se d’altronde ci sarà lieto fine – grazie a un colpo di scena la cui eccezionalità Collins sottolinea con chiarezza, quasi a ricordare che siamo sotto il regime della novel, non della realtà – questo troverà inneschi accidentali nella stessa goffa, disperata, coraggiosa macchinazione della ragazza, non dunque così sterile o biasimevole.
Certo, una lettura tradizionalista può apprezzare la premiata virtù della perfettina Norah, l’affetto coriaceo e profondo di Miss Garth e la serietà professionale con cui l’avvocato Pendril ha cercato (invano) di far ragionare lo zio delle ragazze; ma la desolazione e l’allarme che un po’ tutti mostrano alla rabbia di Magdalen restano in definitiva ancora espressioni del mondo che quegli orrori giuridici e sociali accetta. La società non può riconoscere legittimità alla sua ribellione e il fiato del Male è vicino, ma non ci sono dubbi su chi riceva la solidarietà dell’autore; e persino il capitano Wragge si guadagna un’affettuosa simpatia dei lettori (impagabili le sue avventure ultime, emblematiche di vicende commerciali mai tramontate). Se d’altronde ci sarà lieto fine – grazie a un colpo di scena la cui eccezionalità Collins sottolinea con chiarezza, quasi a ricordare che siamo sotto il regime della novel, non della realtà – questo troverà inneschi accidentali nella stessa goffa, disperata, coraggiosa macchinazione della ragazza, non dunque così sterile o biasimevole.
Nel romanzo tornano temi classici d’epoca, come il sonnambulismo dell’ammiraglio Bartram, che regala qualche momento di brivido gotico; e i buffi duetti del vecchio ufficiale con il fedele coetaneo marinaio Mazey ricordano da vicino quelli tra l’ammiraglio Bell e il suo compagno/contraltare marinaio Jack Pringle in un’opera assai più popolare che Collins deve conoscere, il penny dreadful (1845-47) Varney the Vampyre. Il nome di Bartram, del resto, in combinato con la storia di un padre un po’ troppo candido e di un pessimo zio, tornerà citato in omaggio a Collins nell’Uncle Silas – A tale of Bartram-Haugh di Le Fanu, uscito due anni dopo (1864). E alcuni passaggi potrebbero aver lasciato memorie anche più durevoli all’autore di Carmilla: come quello in cui Mrs. Lecount riflette sulla ragazza che sta prendendo potere sul suo padrone. “C’era qualcosa di vagamente familiare nella voce di questa Miss Bygrave e, allo stesso tempo, in contraddizione inesplicabile, anche qualcosa di sconosciuto”: uno spiazzante conosciuto/non riconosciuto che da maestri come Collins e Le Fanu passerà tra le mani di Freud e conosciamo come Perturbante.
franco.pezzini1@tin.it
F Pezzini è saggista


