In quell’aria che era anche acqua
recensione di Stefano Zangrando
dal numero di giugno 2017
Enrico De Vivo
POCHE PAROLE CHE NON RICORDO PIÙ
pp. 166, € 14
Exòrma, Roma 2017
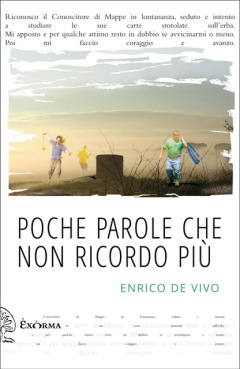 C’è una strana forma di saggezza nel libro di Enrico De Vivo Poche parole che non ricordo più. Dell’autore salernitano erano già note certe imprese e frequentazioni, come la direzione della storica rivista on line “Zibaldoni e altre meraviglie” o la collaborazione, culminata in due pubblicazioni per Feltrinelli, con Gianni Celati. Ora la lezione di quest’ultimo sembra essere fra i principali debiti di questo libro poco catalogabile, sempre a un passo dall’allegoria, ma capace di serbare a ogni riga la grazia dell’indefinito. Gargiulo, l’amico musicista del narratore, introduce nelle prime pagine un motivo, quello di un’armonia primigenia fra le cose, che attraversa l’intero volume: si tratta di imparare a seguire “solo ritmo e cadenze”, e tutto finirà per manifestarsi in una naturalezza pre-logica: le voci, i gesti, la “conoscenza” che procede dall’eros dell’oracolare Rossana, capace di annunciare la prossima rigenerazione di una “Poesia” non più scritta né individuale – e pure la vita associata, come quella che contraddistingue gli abitanti della valle del lago, immersi in una “non umanità” simbiotica, perché ormai disciolti “in quell’aria che era anche acqua”. È quindi esplorando questa sorta di utopia che cogliamo un po’ alla volta l’intento critico che soggiace alla narrazione: qui, tra i “dimenticati” che percepiscono il mondo per “macchie armonizzate”, regna un’“amicizia naturale” disinteressata, i libri sono “rarissimi”, i segni grafici spesso illeggibili, tutto è immerso in una stessa “partitura” sempre diversa, lo “studio” non permette conoscenze a lungo termine, nulla dura ma tutto persiste in una blanda mutazione permanente. Non mancano demoni e malinconie, e quando l’irrequietezza spinge gli abitanti a cercare un altrove, grazie al “Conoscitore di mappe” finiscono tutti quanti in uno stesso posto, ma che per incanto corrisponde a quel che ognuno, memore di un “desiderio antico”, aveva sognato. Tutto ciò mentre la morte, a scongiurare troppo facili paradisi, “è come il motore immobile di ogni cosa”.
C’è una strana forma di saggezza nel libro di Enrico De Vivo Poche parole che non ricordo più. Dell’autore salernitano erano già note certe imprese e frequentazioni, come la direzione della storica rivista on line “Zibaldoni e altre meraviglie” o la collaborazione, culminata in due pubblicazioni per Feltrinelli, con Gianni Celati. Ora la lezione di quest’ultimo sembra essere fra i principali debiti di questo libro poco catalogabile, sempre a un passo dall’allegoria, ma capace di serbare a ogni riga la grazia dell’indefinito. Gargiulo, l’amico musicista del narratore, introduce nelle prime pagine un motivo, quello di un’armonia primigenia fra le cose, che attraversa l’intero volume: si tratta di imparare a seguire “solo ritmo e cadenze”, e tutto finirà per manifestarsi in una naturalezza pre-logica: le voci, i gesti, la “conoscenza” che procede dall’eros dell’oracolare Rossana, capace di annunciare la prossima rigenerazione di una “Poesia” non più scritta né individuale – e pure la vita associata, come quella che contraddistingue gli abitanti della valle del lago, immersi in una “non umanità” simbiotica, perché ormai disciolti “in quell’aria che era anche acqua”. È quindi esplorando questa sorta di utopia che cogliamo un po’ alla volta l’intento critico che soggiace alla narrazione: qui, tra i “dimenticati” che percepiscono il mondo per “macchie armonizzate”, regna un’“amicizia naturale” disinteressata, i libri sono “rarissimi”, i segni grafici spesso illeggibili, tutto è immerso in una stessa “partitura” sempre diversa, lo “studio” non permette conoscenze a lungo termine, nulla dura ma tutto persiste in una blanda mutazione permanente. Non mancano demoni e malinconie, e quando l’irrequietezza spinge gli abitanti a cercare un altrove, grazie al “Conoscitore di mappe” finiscono tutti quanti in uno stesso posto, ma che per incanto corrisponde a quel che ognuno, memore di un “desiderio antico”, aveva sognato. Tutto ciò mentre la morte, a scongiurare troppo facili paradisi, “è come il motore immobile di ogni cosa”.
Viaggio e sogno si compenetrano anche nella seconda parte del libro, dove una galleria di personaggi più o meno bizzarri, dediti ognuno a suo modo a un’“arte poetica-filosofica” dalle tinte vichiane, sviluppano ulteriormente quello che infine appare come un delicato rovesciamento carnevalesco della nostra esistenza debordante pretese e vanità. I loro racconti – l’incontro di Gennaro il piastrellista con i fantasmi di uomini illustri, Torquato Scapece al cospetto di un felliniano varietà notturno in un campo di patate, le “allucinazioni” prospettiche di Felice Sportiello, le lettere dal manicomio di Agostino Barbella, e così via – danno espressione a un universo popolare e clownesco dove l’oralità scalza la parola scritta e una scanzonata vaghezza regna su ogni cosa. Forse non è un caso se l’autore di questa recensione ritenga di aver colto il senso profondo del testo dopo aver vagolato nei caotici, affollati padiglioni di una fiera del libro nel nord Italia, tra commerci e vanaglorie: trovato finalmente un angolo appartato, il brano in cui certi “grandi professori” capitati in un paesino di montagna si imbattono in un reading circense dove i pagliacci declamano i nomi dell’elenco telefonico ha potuto rivelare appieno la sua comica, luminosa verità: “Facciamo ridere la gente o siamo solo tasselli di un mosaico, ma non ce ne accorgiamo” intuisce un professorone, “cioè non ci accorgiamo che far ridere o stare in un mosaico è la cosa più sensata che ci può capitare stando al mondo”.
stezangrando@gmail.com
S Zangrando è insegnante e traduttore


