Una piccola storia intessuta nel grande manto sepolcrale
recensione di Elvio Guagnini
dal numero di ottobre 2015
Daša Drndić
TRIESTE
Un romanzo documentario
ed. orig 2013, trad. dallo sloveno di Liliana Avirović
pp. 444, € 19
Bompiani, Milano 2015
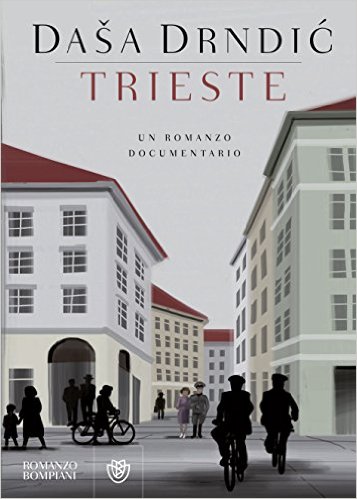 Il titolo è Trieste, ma non si tratta di un libro solo su Trieste. La città compare come luogo degli incontri che la protagonista ha, in tempo di guerra, con un tedesco – membro delle SS – con il quale intreccia una relazione; a Trieste (incorporata, negli anni della seconda guerra, nell’Adriatisches Küstenland sotto il controllo diretto del Terzo Reich) i nazisti danno vita alla Risiera, a un lager con forno crematorio, unico in Italia, e punto di avvio per molti altri lager del centro Europa.
Il titolo è Trieste, ma non si tratta di un libro solo su Trieste. La città compare come luogo degli incontri che la protagonista ha, in tempo di guerra, con un tedesco – membro delle SS – con il quale intreccia una relazione; a Trieste (incorporata, negli anni della seconda guerra, nell’Adriatisches Küstenland sotto il controllo diretto del Terzo Reich) i nazisti danno vita alla Risiera, a un lager con forno crematorio, unico in Italia, e punto di avvio per molti altri lager del centro Europa.
Certo, Trieste è al centro di un ampio territorio in cui si muovono le pagine di questo libro (da Gorizia alla Boemia, dal Friuli a Napoli, a Treblinka e ai tanti luoghi tristemente noti per essere stati sede di lager nazisti, da Milano a Zurigo, a Bad Arolsen, a Norimberga, a Salisburgo, a Gmunden, a Monaco, a Oslo, a Ludwigsburg). Sono solo pochi nomi di una complessa geografia nella quale si muovono le innumerevoli figure che compongono quest’opera dalle dimensioni copiose, per cui, da più parti, si è parlato di un capolavoro: un’opera particolare, a partire dalla struttura, che vuol essere quella di un romanzo documentario. L’autrice ha ricordato di aver intrecciato, in questo libro, “eventi accaduti e fatti immaginari” aggiungendo anche di sentirsi soddisfatta del fatto che i lettori fossero “talmente sorpresi da non distinguere più cosa è reale e cosa è inventato”. Un impasto arduo, dunque, di materiale documentario e di un’invenzione che prende lo spunto da (e si innesta su) suggerimenti veri offerti da fatti di cronaca, accadimenti reali, suggestioni di vario genere anche letterarie.
Anche la vicenda narrativa, immaginaria, del libro intreccia personaggi di invenzione e personaggi reali. Da un lato, una famiglia goriziana di ebrei divenuti cattolici – i tedeschi – alla quale appartiene la protagonista, Haya. Dall’altro, un personaggio che appartiene alla storia tragica del nazismo, Kurt Franz, con interessi sportivi e musicali, membro del partito nazista e poi delle SS, uno dei responsabili del lager di Treblinka, poi assegnato a Trieste con compiti di repressione antipartigiana e antiebraica. Alla fine della guerra si rifugia in Germania, per vivere una vita normale fino a quando viene condannato all’ergastolo (nel 1965) per i crimini commessi. Il bel Kurt Franz, detto Lalka (in polacco: bambolotto) conosce Haya nella tabaccheria di Gorizia, in cui la giovane lavora: un amore a prima vista vissuto tra Gorizia e Trieste, che ha come conseguenza la nascita, nel 1944, di un bambino, Antonio, battezzato e registrato con il cognome della madre (Tedeschi), riconosciuto dal padre ma presto rapito per essere affidato (nell’àmbito del progetto Lebensborn, fonte della vita, elaborato dai nazisti per la difesa e l’incremento della “razza ariana”) a una coppia tedesca e perciò diventato Hans Traube.
 Il romanzo narra anche della ricerca incrociata di Haya e poi di Hans-Antonio (dopo aver saputo dalla madre adottiva delle sue origini) per ritrovarsi. Questo filo narrativo muove dalla visitazione e rivisitazione continua, da parte della protagonista, di documenti, fotografie, schede e reperti di ogni genere messi insieme e conservati nella casa di Gorizia. E si traduce in un racconto che, per alcuni tratti, può evocare qualche drammatica pagina di Némirovsky o lo splendido Viaggio nel cuore della Germania (in L’adescamento, Einaudi 1956) di Renzo Rosso, molto ammirato da Carlo Emilio Gadda per il modo in cui veniva giocato il contrasto tra la ricerca del criminale di guerra e l’immagine del padre di famiglia dell’inchiesta del giudice, al servizio dei governi alleati. Si tratta solo di consonanze, anche alla lontana, che dimostrano però l’interesse esercitato sugli scrittori da tematiche complesse di questo genere.
Il romanzo narra anche della ricerca incrociata di Haya e poi di Hans-Antonio (dopo aver saputo dalla madre adottiva delle sue origini) per ritrovarsi. Questo filo narrativo muove dalla visitazione e rivisitazione continua, da parte della protagonista, di documenti, fotografie, schede e reperti di ogni genere messi insieme e conservati nella casa di Gorizia. E si traduce in un racconto che, per alcuni tratti, può evocare qualche drammatica pagina di Némirovsky o lo splendido Viaggio nel cuore della Germania (in L’adescamento, Einaudi 1956) di Renzo Rosso, molto ammirato da Carlo Emilio Gadda per il modo in cui veniva giocato il contrasto tra la ricerca del criminale di guerra e l’immagine del padre di famiglia dell’inchiesta del giudice, al servizio dei governi alleati. Si tratta solo di consonanze, anche alla lontana, che dimostrano però l’interesse esercitato sugli scrittori da tematiche complesse di questo genere.
Ciò detto, è doveroso prendere atto della particolarità di quest’opera. Debitrice, certo, di suggestioni letterarie dichiarate (da Ungaretti a Eliot, Borges, Giono, Bevk, Magris, Rolland, Michelstaedter, Hemingway, Saba, Pound, Campana, Celan, tra i tanti), Drndić intreccia voci di scrittori con testimonianze di personaggi che hanno vissuto l’esperienza tragica dei campi di sterminio, della deportazione, delle leggi razziali. Fa parlare vittime e carnefici. Un libro dalla struttura caleidoscopica dove i tanti frammenti della finzione narrativa, della cronaca, storia di una famiglia, dell’Europa del primo Novecento, si dispongono variamente, costringono il lettore a guardare avanti, indietro, intorno, a ricapitolare, a fare esami di coscienza e anamnesi, in successioni di spezzoni di racconto, testimonianze letterarie e orali, deposizioni giudiziarie, fotografie, diari, alberi genealogici, spartiti musicali, elenchi di deportati, giustiziati, carnefici, programmatori dell’Olocausto. Tanti documenti, tante testimonianze, tanti fatti e punti di vista per documentare la fenomenologia dell’orrore e della distruzione, gli equivoci, le ambiguità, gli eroismi, la paura. Pagine in prima e in terza persona, racconti da punti di vista diversi, interviste, citazioni, statistiche.
Un intarsio complesso, con l’intervento di lingue e prospettive di discorso diverse per condurre il lettore attraverso un percorso costellato da avanzamenti, ritorni, attraversamenti, approfondimenti, digressioni, allargamenti di prospettive, note a piè di pagina e dentro il testo, affastellamenti di notizie, interrogativi davanti a strade che si biforcano, evocazioni di ombre e di viventi, intersezioni di piani temporali e spaziali. Come se l’autrice avesse voluto ‒ al di là della linearità del filo principale del racconto ‒ porre il lettore di fronte alla complessità della sua avventura di ricercatrice, di studiosa, di scrittrice, per dare al lettore l’impressione di partecipare alla polifonica avventura di un’inchiesta e di una presa di coscienza dell’orrore del male in diretta, entrando nella mente della regista di questa conoscenza. Convocando fatti e problemi catalizzati dalla storia di una famiglia e svolti con la convinzione che i nomi sono altrettante storie; e che è necessario guardare dietro e dentro ciò che i nomi evocano, in termini di vicende; e che bisogna contribuire allo svelamento dei paradigmi della sofferenza e delle tragedie della nostra modernità.
Convinta del fatto che ogni ricostruzione è incompleta e non ha fine, la protagonista sa, lucidamente, che la sua è “una storia piccola, una delle infinite storie sugli incontri, sulle tracce preservate dal contatto umano” e che “fino a quando tutte le storie del mondo non si comporranno in un gigantesco, cosmico patchwork a avvolgere la Terra perché possa addormentarsi, la Storia, quel fantasma della realtà, continuerà a lacerare, tagliare, frammentare, rubare brandelli di universo per ricucirli nel proprio manto sepolcrale”. Ma è anche convinta della necessità di opporre qualcosa alle continue falsificazioni che la storia cerca di imporre agli uomini che, coinvolti in queste tragedie direttamente o indirettamente, più o meno dolorosamente, ne portano dentro i segni e ne sono condizionati: “Noi la Storia ce la portiamo nel sangue, e nel nostro sangue la Storia circola in modo silenzioso e distruttivo, e mentre all’esterno non trapela nulla, all’esterno tutto sembra tranquillo, dentro di noi, nel nostro sangue, nelle nostre ossa, la Storia, la nostra Storia ha preso dimora e ha cominciato a erodere le decrepite e miserabili mura dell’immunità che da decenni cerchiamo di innalzare e di fortificare”.
Drndić è attratta dagli scenari affascinanti e terribili di questa storia, oggetto di violenza e di manipolazioni: paesaggi e condizioni esistenziali, fatta dai tanti nomi di vittime, di colpevoli e di conniventi, di molti dei quali non si sa nulla. Per ricostruire questo quadro, anche per conoscere i conniventi, e gli “osservatori silenziosi”, e gli “invisibili” il lavoro sarebbe infinito. Il dossier, lo schedario, la collezione di tessere come quella che Haya cerca di mettere insieme, sembra apparentemente senza senso, insufficiente, perché molti ne rimangono fuori. Ma è necessario, ha detto Drndić in un’intervista, tentare almeno di opporsi, cercare di “scuotere almeno un lettore o due”, opporsi ai revisionismi e cercare di gettare nuova luce su un terribile periodo della storia italiana ed europea, contestando il silenzio o le ambiguità intorno a eventi così drammatici.
guagnini@units.it
E Guagnini è professore emerito di letteratura italiana all’Università di Trieste



