Nelle crepe della lingua
recensione di Anna Chiarloni
dal numero di ottobre 2014
Katja Petrowskaja
FORSE ESTHER
ed. orig. 2014, trad. dal tedesco di Ada Vigliani
pp. 239, € 19
Adelphi, Milano 2014
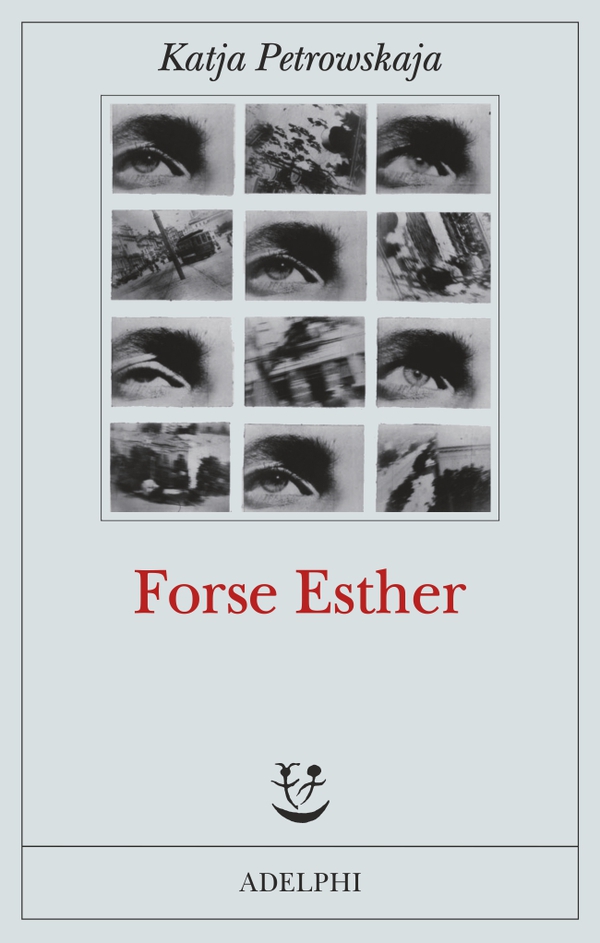 Una nuova voce di rango ci viene dalla Germania, quella della debuttante Katja Petrowskaja. Nata nel 1970 a Kiev da genitori ebrei, immigrata non ancora trentenne a Berlino, Petrowskaja ha vinto nel 2013 il prestigioso premio Bachmann. Al copioso filone della Migrantenliteratur si aggiunge così un innesto di provenienza ucraina, amplificato da molteplici ascendenze familiari russe. In questo genere letterario prevaleva finora uno sguardo altro, del migrante appunto, solitamente portatore di climi ed esperienze diverse rispetto alla storia tedesca. Basti citare, tra gli ultimi autori di successo, Terezia Mora con il suo retroterra ungherese, il bosniaco Saša Stanišić o ancora il turco Feridun Zaimoglu, che nel suo recente romanzo mette in scena il dramma del Kosovo.
Una nuova voce di rango ci viene dalla Germania, quella della debuttante Katja Petrowskaja. Nata nel 1970 a Kiev da genitori ebrei, immigrata non ancora trentenne a Berlino, Petrowskaja ha vinto nel 2013 il prestigioso premio Bachmann. Al copioso filone della Migrantenliteratur si aggiunge così un innesto di provenienza ucraina, amplificato da molteplici ascendenze familiari russe. In questo genere letterario prevaleva finora uno sguardo altro, del migrante appunto, solitamente portatore di climi ed esperienze diverse rispetto alla storia tedesca. Basti citare, tra gli ultimi autori di successo, Terezia Mora con il suo retroterra ungherese, il bosniaco Saša Stanišić o ancora il turco Feridun Zaimoglu, che nel suo recente romanzo mette in scena il dramma del Kosovo.
Con Vielleicht Esther, invece, il lettore è immerso fin dal prologo, maliziosamente intitolato Sia ringraziato Google, nel flusso del passato tedesco. Non solo. Ancora ben visibile è nel presente l’impronta della guerra, segnalata dalla frequenza del termine Krieg che costella le prime pagine. A Berlino resta infatti un “vuoto che nessun governo può colmare, né con costruzioni colossali, né con le buone intenzioni”. E il passato resta annidato nel linguaggio comune; Selektion, Endstation: parole che precipitano l’io narrante all’indietro nel tempo, in un lessico dal suono sinistro, quello dello sterminio nazista. Immagini e parole che accompagnano l’autrice nel suo cammino à rebours, in una contrattazione continua con la lingua di adozione, alla ricerca di una famiglia rimossa anche dalla memoria domestica. È la stessa autrice a introdurci nella sua officina letteraria: “Pensavo in russo, cercavo i miei parenti yiddish e scrivevo in tedesco. Avevo la fortuna di potermi muovere nelle crepe della lingua, nello scambio e nella variazione continua dei ruoli e dei punti di vista”.
Come molti autori di ascendenza ebraica impegnati negli ultimi anni in un recupero delle proprie radici (da Monika Maron a Maxim Leo), anche Petrowskaja scrive in prima persona, corredando il testo, Winfried Sebald insegna, con diverse fotografie. Ma se la coincidenza tra autore e io narrante tende per sua natura a certificare la veridicità del racconto, va subito detto che la scrittura di Petrowskaja rivela una fame di nuovo. Punteggiata da frammenti sia inglesi che russi, e contraddistinta da un carattere ansante e analogico, non ha un andamento documentario ma procede piuttosto per irrequieti volteggi e picchiate introspettive che, pur basandosi su fonti storiche, talora mediate da internet, non ignorano l’invenzione, perché “chi non mente non è capace di volare”. E vola lontano, Petrowskaja, lungo una rotta europea che passa da Kiev e Vienna, Varsavia e Mosca, fino alla Siberia dei gulag staliniani, per ricomporre la dispersa genealogia dei suoi affetti familiari.
Il racconto si apre sulla gigantesca stazione Hauptbahnhof di Berlino, nota al turista come uno dei marchingegni più poderosi della riunificazione ma, annota Petrowskaja, luogo “del tutto inospitale”, spalancato sulla “desolazione” di una città da cui si è mossa, “su ruote e ali di ferro, una guerra lampo senza fine”. “Certo, è passato molto tempo” concede l’autrice, pronta tuttavia al guizzo attualizzante: “Oggi la città è tra le più pacifiche del mondo e produce pace in modo quasi aggressivo, nelle forme di una memoria militare”. L’allusione ironica a un’inevitabile carattere bellico del pensiero tedesco, invero un po’ impietosa, tenuto conto della profonda e perdurante rielaborazione del passato nazista, è sostenuta nel racconto dalla presenza di una metallica scritta di benvenuto che incombe a caratteri cubitali dall’arcata della stazione: Bombardier Willkommen in Berlin. Un’insegna “spietata”, che di fatto“bombarda” gli ignari passeggeri in arrivo nella capitale con immagini di morte, pur trattandosi, come si saprà appunto grazie a Google, della campagna pubblicitaria di una ditta aeronautica canadese. Resta “la potenziale violenza” di un linguaggio mercificato, ma tutto è ormai lecito, questo il sottinteso, in un mondo dominato dall’etica del commercio. Una violenza che risuona “senza scampo” dentro di noi, osserva la scrittrice, rendendoci tutti “esseri miserabili”. E qui Petrowskaja richiama chi legge ben oltre l’orizzonte autobiografico, collegando il teatro delle rovine tedesche a un “noi” succube e smemorato, anche goffo, che tutto dimentica pur di ingoiare moneta e fare cassa.
Centrale in Forse Esther è però il rapporto con l’ebraismo di una scrittrice cresciuta in un ambiente familiare assimilato. Composto da Storie (mirabilmente tradotte da Ada Vigliani), il libro ripercorre una “felice” infanzia sovietica ignara di qualsiasi appartenenza religiosa, in una Kiev dedita al culto di Lenin, narrato con godibili risvolti comici, insediato come nonno sultano nelle teste bambine, in marcia “per due al comando Avanti Marx!”. Solo più tardi, grazie a un disco polacco di canti yiddish, si apre per Petrowskaja “la finestra sigillata dell’infanzia”.
Dalle melodie della vecchia Varsavia prende avvio il viaggio di “un’ebrea per caso”, che indaga la storia est-europea dando voce a figure sepolte nell’oblio. Un coro a voci nude di personaggi remoti, dal rivoluzionario bolscevico al fisico epurato da Stalin, dalla nonna cieca, generosa e discreta come un’ombra, alla compagna comunista fiera del suo Molotov, fino all’antenato che nella Vienna ottocentesca fonda scuole per bambini sordomuti. Lacunosi i contorni, e talora incerto anche il nome: era forse Esther la babuschka uccisa nel 1941 a Babij Jar? Decisivi nella ricostruzione di Petrowskaja sono i luoghi del massacro, come Auschwitz e Mauthausen. Una ricerca nei sotterranei della storia, fino allo sfinimento dell’io narrante. Corpi offesi, a grappolo sulla pagina, tra spazi vuoti in cui si legge il silenzio del lutto. Sfilano cognomi migrati nella diaspora, identità mutate e timbrate dai diversi passaggi di regime e confine nell’Europa tra Otto e Novecento.
Più vicino nel tempo è il nonno Wassilij, recluso prima in un lager nazista, poi nel gulag staliniano, infine in un silenzio “nutrito solo dal sorriso: non una parola sulla guerra, non una sul passato”. Ritorna con questa figura un tema diffuso tra gli autori ebrei di terza generazione in cerca di un’identità dismessa, o per necessità occultata: il bisogno di condividere nel ricordo la tragedia della persecuzione, spesso taciuta dai superstiti per risparmiare alla prole l’orrore. Si tratta ora di fare storia per compensare quella “perdita”, e ogni reperto diventa prezioso nella ricerca interrogante di Petrowskaja. Gli oggetti parlano ancora il dolce rumore della vita dei defunti: dalla molletta dei capelli alla ricetta yiddish della zia Lida, ogni dettaglio è conoscenza che chiede di incastonarsi nella scrittura per non scomparire nel nulla. Da questa raccolta di memorie nomadi, voci e gesti, cibi e danze nasce, tra lo scampanio di versi russi, un insieme di figure palpitanti, presenze vitali che Petrowskaja, sfidando un tempo di morte, convoca nel sogno ricorrente di “un grande desco familiare” che possa radunare tutti i congiunti scomparsi.
Un atto di resistenza, una volontà di permanenza che apre il testo, come osserva Samuel Moser, a una dimensione metafisica (“Neue Zürcher Zeitung”, 5 aprile 2014). Ha entusiasmato la critica tedesca, Forse Esther. Certo, con la sua tensione visionaria che procede con una pulsazione ritmica costante, con folate di suoni e di lingue diverse, capaci di fondere comicità e tragedia, il libro s’impone per un’originalità di scrittura che rivela una drammaturgia sorprendente. Lo denota anche il finale, quasi l’eco di una Tafelmusik: dalla sua specola tedesca Petrowskaja immagina il ritorno alla casa dell’infanzia di Kiev. Una Heimat residuale, forse, oggi ricacciata nel fango del conflitto, ma che ancora dichiara le radici di un’appartenenza.
anna.chiarloni@unito.it
A Chiarloni insegna letteratura tedesca all’Università di Torino
Un personaggio da road movie: anche Roberta Ascarelli ha commentato Forse Esther per il numero di ottobre 2014.



