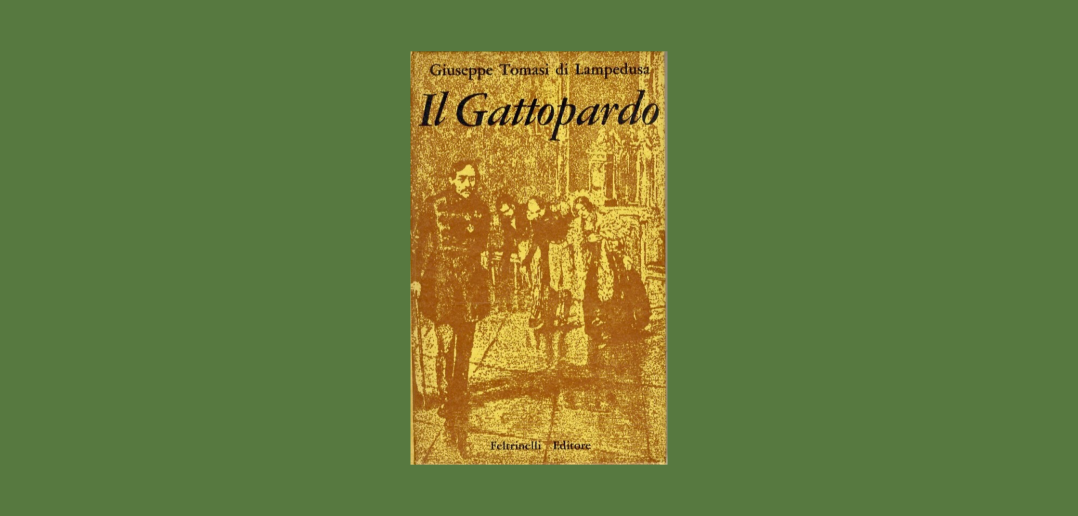Leggere tra le righe
di Carlo Ginzburg
Il testo che segue si basa su una lezione tenuta all’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, il 19 febbraio 2015
Termini come “gattopardesco” e “gattopardismo” sono entrati da tempo stabilmente nella lingua italiana. Com’è noto, essi si riferiscono al passo del Gattopardo in cui il giovane Fabrizio Falconeri si rivolge allo zio, don Fabrizio, principe di Salina, commentando l’avanzata di Garibaldi in Sicilia: “Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato?” Secondo l’opinione corrente la frase, diventata subito famosa, “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”, racchiuderebbe il significato del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Nell’accesa discussione che seguì la pubblicazione postuma del Gattopardo qualcuno, da sinistra, parlò di “antistoricismo”; molti criticarono l’autore attribuendogli una visione immobile della storia. In una conferenza tenuta nel 1959, e pubblicata postuma col titolo Contro Il Gattopardo, Franco Fortini dichiarò senza mezzi termini: “Il rifiuto della storia che c’è in questo libro non è rifiuto di questa o quella storia ma rifiuto del mutamento in sé”. Spesso questi giudizi presuppongono, come notò Nunzio La Fauci, “quella spiccia identificazione tra il protagonista del romanzo e il suo autore (…) che (…) costituisce uno dei tratti caratterizzanti della letteratura critica sul Gattopardo”. Non solo: l’interpretazione corrente di quella frase, ossia la vulgata del “gattopardismo”, è basata, ha sottolineato La Fauci, su un fraintendimento: “Il famosissimo ‘Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi’ non può che rappresentare un pensiero che assegna tempi e spazi alla capacità umana di progetto, che colloca l’agire nell’universo delle possibilità piuttosto che in quello delle limitazioni. Il pensiero di chi si sente parte, e parte attiva, della storia”.
Il filo diretto tra Machiavelli e Tomasi di Lampedusa
Sono osservazioni pertinenti; ma per capire meglio il significato del famoso passo è utile individuarne la “fonte”, ossia il testo che ne costituisce, rovesciato, il punto di partenza. Si tratta di un brano dei Discorsi di Machiavelli, (libro I, capitolo 25) Chi vuole riformare uno stato anticato in una città libera, ritenga almeno l’ombra de’ modi antichi: “Colui che desidera o che vuole riformare uno stato d’una città, a volere che sia accetto e poterlo con satisfazione di ciascuno mantenere, è necessitato a ritenere l’ombra almanco de’ modi antichi, acciò che a’ popoli non paia avere mutato ordine, ancorché in fatto gli ordini nuovi fussero al tutto alieni dai passati; perché lo universale degli uomini si pascono così di quel che pare che di quello che è: anzi molte volte si muovono più per le cose che paiono che per quelle che sono”. Non mi risulta che questa derivazione (rovesciata) da Machiavelli sia stato segnalata. Il bersaglio è stato sfiorato da Francesco Orlando, che nel respingere l’uso corrente dei termini “gattopardesco” e “gattopardismo”, derivati dalla “purtroppo famosa” frase di Tancredi, si è chiesto: “Un pregiudizio diventato lingua è praticamente incorreggibile – da quanti secoli sarebbe vano purgare del loro senso deteriore machiavellismo e machiavellico?” Un atto mancato, di pochissimo.
Nel corso del romanzo don Fabrizio torna più volte, tra sé e sé, sulle parole del nipote, delle quali a poco a poco capisce il significato profondo. Per esempio: “Tancredi, secondo lui, aveva dinanzi a sé un grande avvenire; egli avrebbe potuto essere l’alfiere di un contrattacco che la nobiltà, sotto mutate uniformi, poteva portare contro il nuovo ordine politico”. Qui affiora per un attimo il lessico di Machiavelli: “Ancorché in fatto gli ordini nuovi fussero al tutto alieni dai passati”. Ma al di là dell’eco formale, il rapporto rovesciato tra le parole di Tancredi e il passo di Machiavelli è evidente. Se vogliamo che tutto cambi bisogna che qualcosa rimanga com’è (Discorsi); “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” (Il Gattopardo). Il fine è opposto: rivoluzione nel primo caso, conservazione nel secondo. Il mezzo è simile: cambiamento (parziale nel primo caso, totale nel secondo). Chi spinge il paradosso all’estremo (“tutto… tutto”) è il conservatore, non il rivoluzionario. Ma è possibile definire “conservatore” colui che vede nel cambiamento di “tutto” l’unica soluzione? Non sarà meglio definirlo un reazionario? si chiedeva Fortini. E chi è costui: il personaggio o l’autore? Tancredi, seguito da don Fabrizio, oppure Lampedusa? Nell’accenno, che si legge in un passo del Gattopardo, al “machiavellismo incolto dei siciliani”, risuona la voce sprezzante del coltissimo, sicilianissimo autore. Altri passi sono meno trasparenti. In una lettera all’amico Guido Lajolo del 31 marzo 1956 Lampedusa scriveva, parlando del proprio romanzo: “Bisogna leggerlo con grande attenzione perché ogni parola è pesata e ogni episodio ha un senso nascosto”. Nel suo bellissimo Ricordo di Lampedusa Orlando rievocò la predilezione di Lampedusa per l’implicito, in cui convergevano il gusto del letterato (la scelta a favore degli scrittori “magri”) e l’ostentazione aristocratica. E trattandosi di Machiavelli, l’implicito era di rigore, come osservò Lampedusa nelle sue lezioni sulla letteratura inglese: “Machiavelli è autore che si può, e forse si deve, seguire in politica, ma a patto di rinnegarlo pubblicamente, se no non si è più machiavellici”. Anche Tancredi, nel momento in cui riprendeva, rovesciandola, una massima di Machiavelli, che avrebbe ispirato la sua strategia matrimoniale, non avrebbe potuto dichiarare il proprio debito. Leggere Il Gattopardo (e qualunque altro libro) tra le righe non solo si può, ma si deve: magari per cogliere allusioni non dichiarate, rivolte agli happy few cui Stendhal, amatissimo da Lampedusa, aveva dedicato la Chartreuse. La decifrazione di queste allusioni, letterarie o meno, fa parte del mestiere del critico da tempi remotissimi, quando il termine “intertestualità” era di là da venire. Per questo non riesco ad accettare la pagina in cui Orlando, nel suo libro sul Gattopardo, respinge l’intertestualità (termine certo superfluo), sottolineando, in tono apparentemente scherzoso ma serio, che la lettura non può fare a meno di concentrarsi, di volta in volta, su un unico testo: “Uno alla volta, per carità!” Orlando stesso ha mostrato la ricchezza di ciò che in quella pagina liquida bruscamente come “operazione riflessa da laboratorio”: basti pensare a un libro come Illuminismo, barocco, e retorica freudiana (Einaudi, 1997), che legge in filigrana Pascal dietro la polemica antireligiosa degli illuministi. Ma che cosa aggiunge alla lettura del Gattopardo il riconoscimento del debito (rovesciato) nei confronti del passo dei Discorsi?
Le obiezioni di Orlando
“La vulgata” ha scritto Francesco Orlando “ ha trasformato in morale della favola una proposta tre volte infida: non inventata dal libero arbitrio del narratore, non convalidata dagli sviluppi ultimi del racconto, conforme alla materia storica soprattutto come illusione”. Provo a esaminare queste obiezioni cominciando dall’ultima. In un ambito non siciliano ma europeo, la strategia delineata e poi praticata da Tancredi (venire a patti con la borghesia per assicurare la sopravvivenza dell’aristocrazia) fu tutt’altro che illusoria: lo ha mostrato Arno Mayer in un libro originale, che analizza la persistenza di elementi dell’ancien régime fino alla prima guerra mondiale. La seconda obiezione sembra più pertinente: alla fine del Gattopardo, il cadavere imbalsamato del cane Bendicò che, gettato dalla finestra, si trasfigura per un attimo nell’animale araldico dei Salina, ne simboleggia la fine. Ma il titolo scelto Rimane la prima obiezione mossa da Orlando: “Non inventata (la frase di Tancredi) dal libero arbitrio del narratore”. Immagino che Orlando volesse sottolineare che chi pronuncia la frase non è il narratore bensì un personaggio, che, una volta creato, costituisce un vincolo per il narratore stesso. Ma le parole di Tancredi riaffiorano con insistenza nei monologhi del protagonista, don Fabrizio, che le fa proprie: “‘Trattative punteggiate da schioppettate quasi innocue e, dopo, tutto sarà lo stesso mentre tutto sarà cambiato’. Gli erano tornate in mente le parole ambigue di Tancredi che adesso però comprendeva a fondo (…) ‘Perché tutto resti com’è’. Come è, nel fondo: soltanto, una lenta sostituzione di ceti”.Nell’ultima battuta la voce del protagonista e quella del narratore si confondono. Lampedusa può aver sentito la contiguità tra le due voci come un pericolo. In qualche caso volle distinguerle, come nelle riflessioni di don Fabrizio sulla manipolazione dei risultati del referendum che sancisce l’annessione della Sicilia al regno d’Italia: “A questo punto la calma discese su Don Fabrizio che finalmente aveva sciolto l’enigma; adesso sapeva chi era stato strangolato a Donnafugata, in cento altri luoghi, nel corso di quella nottata di vento lercio: una neonata, la buonafede (…) Don Fabrizio non poteva saperlo allora, ma una parte della neghittosità, dell’acquiescenza per la quale durante i decenni seguenti si doveva vituperare la gente del Mezzogiorno, ebbe la propria origine nello stupido annullamento della prima espressione di libertà che a questo popolo si era mai presentata” (corsivi miei). Ma l’impulso che spinge l’autore a parlare per interposta persona gli suggerisce, nel caso del colonnello Pallavicino (l’unico personaggio del romanzo storicamente esistito) un espediente non privo di goffaggine: “‘Per il momento, per merito anche del vostro umile servo, delle camicie rosse non si parla più, ma se ne riparlerà. Quando saranno scomparse queste ne verranno altre di diverso colore: e poi di nuovo rosse. E come andrà a finire? C’è lo Stellone, si dice. Sarà. Ma Lei sa meglio di me, principe, che anche le stelle fisse veramente fisse non sono’. Forse un po’ brillo, profetava. Don Fabrizio dinanzi alle prospettive inquietanti si sentiva stringere il cuore”.
Le implicazioni autobiografiche di questo passo sono evidenti. Alle elezioni del 1948, dove il simbolo del Fronte popolare esibiva l’immagine di Garibaldi (il ritorno delle camicie rosse) era seguita la riforma agraria del 1950, che aveva sancito in maniera irreversibile il declino dell’aristocrazia siciliana. Le pagine più alte del romanzo (il ballo, la morte del protagonista) si nutrono della consapevolezza di questo declino, ben diversa dal “rifiuto del mutamento in sé” di cui parlò a torto Fortini. Nel Gattopardo il mutamento politico esiste, così come esiste, a un livello più profondo, la “lenta sostituzione di ceti” che l’autore evoca attraverso le riflessioni di don Fabrizio sulle parole di Tancredi. Ma c’è qualcosa di più profondo ancora, il paesaggio della Sicilia, in cui è inscritta un’arretratezza immutabile: “Guardava i fianchi di Monte Pellegrino, arsicci, scavati ed eterni come la miseria”. Chi guarda è don Fabrizio: “La visione del monte presso Palermo materializza una disperazione che si pensa metastorica”, cioè eterna, “perché nessun tempo di vita umana basterebbe a provarla illusoria” commenta Orlando. Ma un altro studioso, Edward Reichel, ha sostenuto che qui emerge una prospettiva condivisa da Lampedusa stesso. L’immagine della storia presentata nel Gattopardo si articolerebbe secondo tre ritmi: uno quasi immobile, condizionato dalla geografia e dal clima; uno lento, costituito della storia sociale; uno rapido ed effimero, raffigurato nelle vicende dei personaggi. Reichel ha sottolineato le analogie tra quest’immagine della storia e quella proposta da Fernand Braudel nel suo libro sul Mediterraneo. Sarebbe, questa, una mera convergenza: anche se, informa Fabien Kunz, una copia dell’opera di Braudel si trova in quello che rimane della biblioteca di Lampedusa.
Meno ipotetica, e più vicina a Lampedusa, mi pare una lettura imperniata su parole che tornano a più riprese nel romanzo: “eterno”, “eternità”. Ecco don Fabrizio che si rivolge al gesuita don Pirrone: “Viviamo in una realtà mobile alla quale cerchiamo di adattarci come le alghe si piegano sotto la spinta del mare. Alla Santa Chiesa è stata esplicitamente promessa l’immortalità; a noi, in quanto classe sociale, no. Per noi un palliativo che promette di durare cento anni equivale all’eternità” (corsivo mio). Ancora don Fabrizio, dopo il colloquio con il nobile piemontese Chevalley di Monterzuolo: “Il principe era depresso: ‘Tutto questo’ pensava ‘non dovrebbe poter durare; però durerà, sempre; il sempre umano, beninteso, un secolo, due secoli…; sarà diverso, ma peggiore. Noi fummo i Gattopardi, i Leoni; quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti Gattopardi, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra’” (corsivo mio). In quest’ultimo passo il personaggio prende le distanze da se stesso (“Noi fummo”), e l’autore prende le distanze dal personaggio (“Continueremo a crederci”). Siamo nel tempo lento della storia sociale, in cui cento o duecento anni equivalgono all’eternità. La storia condizionata dal clima è più lenta ancora: “Guardava i fianchi di Monte Pellegrino, arsicci, scavati ed eterni come la miseria”. Ma l’eternità, in una prospettiva non umana, è tutt’altro: è l’eternità degli astri, che il principe astronomo contempla col suo cannocchiale. La morte, quando arriva, gli appare come una donna, come un astro, “più bella di come mai l’avesse intravista negli spazi stellari”.
“Le silence éternel de ces éspaces infinis m’effraie”. “Chiunque voglia chiamarsi un uomo e non un animale a due gambe” diceva Lampedusa “deve aver letto i Pensieri di Pascal”. Il Gattopardo, un romanzo sulla storia e sui tentativi di alcuni personaggi, in un momento e in un luogo determinati, di orientare la storia in atto, è incorniciato da un Pascal letto in chiave scettica. La storia ha un senso per quelli che la fanno o credono di farla, mossi da strategie più o meno machiavelliane; non ha senso dal punto di vista delle stelle. La Fine di tutto, con cui termina l’indice analitico redatto da Lampedusa, allude alla fine dei Salina e alla fine del romanzo: ma è un’espressione evidentemente ironica. La storia umana non è la realtà: su questo punto, al di là di tutte le divergenze possibili, non si può non dar ragione a Lampedusa.